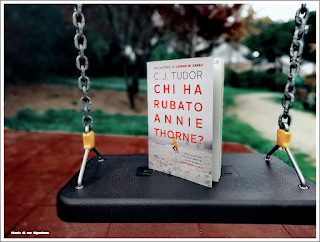|
Le sette morti di Evelyn Hardcastle, di Stuart Turton. Neri
Pozza, € 18, pp. 526 |
Il
thriller mi piace contemporaneo. Cinematografico, scabroso e cattivo.
Saltando i classici Conan Doyle e Agatha Christie, nel mio
apprendistato di lettore ho bruciato le tappe fondamentali arrivando
in anticipo ai fiumi di sangue e ai detective dalla coscienza
macchiata. Il giallo all'inglese, tutto supposizioni e dita puntate,
insomma, non mi attrae. A meno che, come in questo caso, non presenti
uno splendido incentivo. Sono stati un colpo di genio e uno strappo
alla regola a portarmi nella sala da ballo di Stuart Turton. Un
esordiente ingegnoso e sfacciato che alza l'asticella del rischio,
unendo al rigore di Assassinio sull'Orient-Express i
viaggi temporali di Auguri per la tua morte
e le reincarnazioni new age di Ogni giorno.
Lo stile: di quelli semplici e funzionali, senza grandi fronzoli,
interessati più ai fatti che ai personaggi. Ogni parola dell'autore
britannico, infatti, è al servizio di una storia di rara
complessità: una descrizione in eccesso, una digressione in più,
rischierebbero di ostruire un meccanismo a orologeria che, purtroppo
o per fortuna, bada alla sostanza e non alla forma.
Alle
undici in punto, durante la festa organizzata per il suo ritorno dal
collegio a Parigi, Evelyn Hardcastle si sparerà un colpo in pancia
mentre la notte è squarciata dalle scintille dei fuochi artificiali.
Chi l'ha spinta a tanto? Come si collega il suo destino al delitto di
diciannove anni prima, quando un guardiano e un complice mai
consegnato alla giustizia uccisero a sangue freddo il fratellino
Thomas? Tutti hanno segreti e moventi. Tutti hanno alibi
incrollabili. Tutti hanno scheletri nell'armadio, ben agghindati come
si confà a una festa in maschera. I padroni di casa sono stranamente
assenti. Gli invitati contano il peggio dell'aristocrazia locale:
stupratori, strozzini, spacciatori di laudano, cacciatori e
cacciati.
Questa girandola temporale dalle leggi da scoprire, assurde ma sorprendentemente coerenti, ci fa presto suoi grazie ai capitoli brevi e a una scrittura scorrevolissima, nonostante la narrazione ad ampio respiro a tratti possa mettere alla prova.
Questa girandola temporale dalle leggi da scoprire, assurde ma sorprendentemente coerenti, ci fa presto suoi grazie ai capitoli brevi e a una scrittura scorrevolissima, nonostante la narrazione ad ampio respiro a tratti possa mettere alla prova.
Le
sette morti di Evelyn Hardcastle è
una lettura cervellotica, claustrofobica, forse mai sperimentata
finora. Una macchinazione cosmica dalla mente lucida e il cuore di
ghiaccio con idee fuori dall'ordinario, molto fumo soffiato negli
occhi e innumerevoli comprimari dai ruoli non indispensabili. La
festa organizzata dai tenutari è una commemorazione o un castigo? Il
labirinto rappresentato dalla magione in stato d'abbandono, maestosa
ma sfiorita, è fisico o simbolico? Autentico luogo dell'anima,
Blackheath House è una bolgia infernale che costringe un narratore a
senza identità a un gioco implacabile: risvegliarsi giorno dopo
giorno nel corpo di un ospite diverso, così da acciuffare
l'assassino dall'alto di una fantomatica visione d'insieme.
Quanto
bisogna sentirsi sperduti per lasciare che sia il diavolo a condurci
a casa?
Ora
nei panni di un medico, ora in quelli di un maggiordomo, a volte
rampollo dedito al vizio e altre sbirro squattrinato, il protagonista
fa propri i fardelli dei corpi che lo ospitano – la vecchiaia, il
peso fisico, i pensieri impuri – e rischia di perdersi per sempre.
Ma anche di guadagnare vantaggi, una saggezza aggiunta, per battere
ad armi impari i suoi rivali. Da quando è intrappolato lì, giorni
mesi o anni? Cosa lo muove, l'amore o la vendetta? Può fidarsi di sé
stesso, se non conosce nemmeno il suo nome? Dalle identità degli
altri prende in prestito i pregi e i difetti, l'indole, facendo che
le sue più anime convivano contemporaneamente. Lo stesso misfatto,
così, può essere studiato da punti di vista speculari. Per notare i
dettagli compromettenti, additare il killer e cambiare lo status quo
uscendo dal loop.
Otto
giornate, sessanta capitoli, cinquecentoventi pagine totali. Tre
uniche costanti: la presenza della sfuggente Anna, personaggio fisso
che non compare né fra gli invitati né nel personale di servizio;
il Medico della peste, uomo mascherato che a tempo debito farà da
cicerone e consigliere; il lacchè, sociopatico infallibile che
minaccia di freddare con puntualità ciascuna incarnazione.
Il
futuro non è un avvenimento, amico mio, è una promessa, e non
saremo noi a violarla. È questa la natura della trappola che ci
tiene prigionieri.
Non
servono tutti gli ospiti. Non servono tutte e otto le giornate. Non
servono tutti i figuranti. Inutilmente caotico, senz'altro
eccessivamente affollato, il thriller paranormale è all'altezza
delle proprie ambizioni, ma cavilli, colpi di scena e complessità
strutturali sono insieme un pro e un contro: nel tempo potrebbero
renderlo abbastanza oscuro, infatti, da non farcelo ricordare nel
dettaglio. Abile a confondere i sensi, tuttavia, risulta un'indagine
assolutamente scoppiettante la cui particolarità è un'arma a doppio
taglio. Se Turton la padroneggia con maestria, al contrario potrebbe far
incontrare qualche ostacolo al lettore più incostante: rischieremmo
di perderci, in tal caso, un finale che fa la differenza. Le
sette morti di Evelyn Hardcastle è
una messinscena di maschere impassibili e attori navigati, di conti
da saldare e regole infrante in nome del perdono, che
nell'impensabile scioglimento si arricchisce perfino di riflessioni
dai toni filosofici. Sul perdono. Sull'espiazione. Su gironi
danteschi in cui in fondo non vediamo l'ora di smarrirci, pur di
ritrovarci.
Armatevi
di tempo e pazienza da vendere. Lasciate da un lato penna e taccuino:
le congetture non funzioneranno. Fra pregi e difetti, ne sarà
comunque valsa la pena. Da Blackheath House, se c'è una cosa
garantita, si esce cambiati. Il resto, resta enigma.
Il
mio voto: ★★★★
Il
mio consiglio musicale: Elisa – Labyrinth