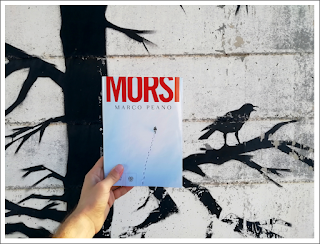Leggo
Hanya Yanagihara per trovare salvezza dai miei lati peggiori. La
scorsa estate, vittima di un'apatia che mi rendeva estraneo al mondo,
mi sono affidato a Una vita come tante in cerca della catarsi
del pianto. A gennaio, invece, isolato in camera insieme al virus e
ai miei soli pensieri, ho atteso l'arrivo di una nuova storia –
anzi, tre – per fuggire lontanissimo da me. Questa volta, lo
ammetto, non avrei tollerato l'ennesimo magnifico struggimento. E
l'autrice, per fortuna, ha avuto grande cura di me e della mia
solitudine: nell'arco di oltre settecento pagine l'ha riempita di
voci. Le sento anche ora, a lettura ultimata, e tento di districarle
a furia di scriverne. Ma si può realmente possedere un romanzo così
ampio, sfuggente, indefinibile? È forse possibile averne a colpo
d'occhio la visione d'insieme? Mi piacerebbe riportare alla mente
tutti i dettagli, grandi e piccoli; individuare la costante in grado
di sbrogliare l'equazione. Ma è impossibile, tanto quanto la pretesa
di scorgere una silhouette claudicante sull'uscio di un condominio di
mattoni: il nostro Jude St. Francis, sappiatelo, non abita lì.
Restano allora le strade di New York, una poetica malinconia di
fondo, una dimensione umana dal calore contagioso e, soprattutto, una
domanda sprovvista di risposte nette: cos'è il paradiso?
Le
amicizie a quell'età sono così fragili, perché quello che sei –
non solo le tue dimensioni fisiche, ma pure quelle emotive – cambia
moltissimo da un mese all'altro. […] Ci eravamo allontanati, non
divisi, e quando ci vedevamo da lontano nei giardini della scuola o
nei corridoi, facevamo un cenno con la testa, o con la mano, i gesti
che faresti in mare, da lontano, dove sai che la voce non si sente.
Quando più di una decina d'anni dopo ci ritrovammo, parve in qualche
modo inevitabile, come se fossimo entrambi andati alla deriva così a
lungo da doverci ritrovare prima o poi.
In
un Ottocento ucronico, la fine della guerra di secessione ha portato
all'indipendenza della città e all'avvento dei matrimoni egualitari.
Immerso in atmosfere degne di Jane Austen, un giovane di ricca
famiglia si scopre combattuto tra il matrimonio combinato con un
vedovo e il sentimento bruciante per un insegnante socialmente
inferiore a lui. Il paradiso è una casa status symbol, già pronta a
essere ereditata, o una tormentosa passione da romanzo d'appendice?
Mentre l'avvento dell'Aids falcia un'intera generazione, un
venticinquenne di nobili origini hawaiane riflette sull'amore e la
morte: i migliori amici del suo partner stanno morendo come mosche e
ogni rimpatriata si trasforma in una festa di addio; il padre
lontano, colpevole di un torto indicibile commesso in nome del
fanatismo, domanda di lui in un delirio struggente. Il paradiso è un
salotto in cui risuonano le chiacchierate di amici un po' attempati,
o l'utopia di restaurare la sovranità hawaiana in trenta ettari? Ci
si sposta nel futuro, infine: l'apocalisse si esprime con un lessico
ormai familiare. Continuamente in balia di virus di differente
entità, il mondo è diventato una distopia in cui vigono la legge
marziale e i baratti, i ribelli vengono massacrati in pubblica piazza
e i matrimoni, combinati con la forza, mirano a scoraggiare
l'omosessualità. Prigioniera di un matrimonio senza amore, una
tecnica di laboratorio segnata dalla malattia fa i conti con
sentimenti nuovi e spaventosi: la gelosia verso il marito, al centro
di una vita parallela; l'attrazione verso l'ultimo arrivato nel
distretto, che osa avanzare quesiti di natura personale; la nostalgia
per il nonno epidemiologo, che in una lunga corrispondenza confessa
amaramente di aver sacrificato gli equilibri della famiglia per la
salvezza della specie. Il paradiso è una società in cui il caos è
arginato con fermezza, o il buio del guado?
Tu
sei tanto giovane; hai passato quasi metà della tua vita vita
accanto alla morte e alla possibilità della morte – ci hai atto il
callo, che è una cosa che mi spezza il cuore. E allora forse non
capirai fino in fondo quel che ti voglio dire. Ma quando si
invecchia, si fa tutto ciò che si può per restare vivi. A volte
nemmeno ti accorgi di farlo. A volte, un istinto, un sé deteriore,
prende il controllo: e perdi ciò che sei. Non succede a tutti. Ma
succede a molti.
Nell'impossibilità
di bissare il successo precedente, Yanagihara spezza le linee
temporali e la compattezza della narrativa americana; spiazza.
Costruisce un dedalo di storie dentro storie, e di epoca in epoca
ripropone nomi di battesimo (David, Edward, Charles) e indirizzi
(Washington Square). Si tratta delle stesse persone in realtà
differenti? Se fossimo in un film, avrebbero gli stessi volti o
sarebbero sconosciuti gli uni agli altri? I nessi, poco manifesti,
vanno cercati unicamente in questa galleria di giovani inetti, nonni
granitici, triangoli sentimentali e famiglie omogenitoriali; in
riflessioni sulle radici culturali e l'identità, sul sangue e sul
crepacuore dei sogni infranti. Quale mondo lasceremo ai nostri figli?
In che mondo li lasceremo? Solidale e spietata, con una scrittura che
è un mare caldo in cui è incantevole immergersi, l'autrice apre
finestre, parentesi, squarci; registra i passi falsi commessi lungo i
cammino dell'utopia. Ma se i genitori sono umani, dunque fallibili
per natura, allora tocca ai loro eredi abbandonare la sicurezza dei
confini già tracciati. Rinunciando, però, a cosa? Affrancarsi
significa costruirsi un paradiso su misura. Lo fanno i protagonisti,
combattuti tra andar via o restare, tradirsi o scoprirsi. Lo fa Hanya
Hanagihara, alle prese con un cambio di rotta che scontenterà più
di qualche accolito. I loro passi – avvolti da una luce misteriosa
– sfumano nella vaghezza dell'incerto, fin quando non distogliamo
finalmente lo sguardo: sono troppo distanti. Verso il paradiso.
Il
mio voto: ★★★★½
Il
mio consiglio musicale: Judy Garland – Somewhere Over The Rainbow