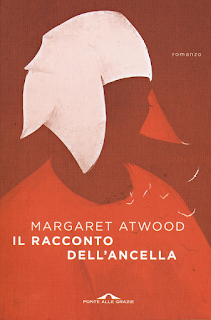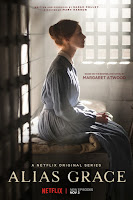In una comunità in gran fermento, erosa all’interno da scandali e corruzione, s’incrociano a qualche anno di distanza dagli eventi del primo capitolo le voci di tre personaggi femminili. Il primo, già noto, è Zia Lydia: aguzzina al solito dotata di carisma e sarcasmo straordinari, nella sua confessione fraudolenta mescola frammenti di un passato come giudice e descrizioni della routine ad Ardua Hall: un covo di donne di potere e corruzione, dove le rivalità all’ultimo sangue fra Zie e le contromosse per frenare il business della fuga costituiscono ormai la norma. In biblioteca, in mezzo a titoli proibiti che comprendono Jane Austen, Thomas Hardy e le sorelle Bronte, i posteri potranno trovare un giorno la sua confessione. Inediti, al contrario, i punti di vista delle altre narratrici mostrano le due facce dell’essere giovani al tempo del regime. Daisy, sedici anni, vive oltre il confine canadese: sfrontata e sicura di sé, è costretta a mettere tutto in discussione alla notizia della dipartita di quei genitori un po’ hippy e davanti a una missione rischiosa – infiltrarsi a Gilead sotto copertura. A Gilead, invece, la timida Agnes ha sempre vissuto all’insegna della cieca obbedienza: case di bambole, gonne fruscianti, una paura inconscia per gli uomini e l’autorità, un ambiente scolastico competitivo e crudele che dà lezioni morali attraverso sanguinosi episodi biblici. Costretta prematuramente a sposarsi, potrebbe sfuggire al suo destino di sposa bambina entrando a far parte delle Supplicanti: meglio diventare una macchina da figli, però, o scendere a patti con le contraddizioni delle Sacre Scritture, con tanto di documenti da insabbiare e messaggi censurati?
Se le prospettive descritte sono parzialmente inedite, gli scenari e le situazioni risultano per forza di cose già esplorati sul piccolo schermo. Più credibile quando alle prese con l’evocazione dei costumi e dei trattamenti più barbari, Margaret Atwood è a disagio con scene d’azione e svolte da film di spionaggio. Soprattutto, pasticcia in maniera imperdonabile – parliamo, infatti, di una signora scrittrice – con segreti di Pulcinella che durano poche pagine appena e colpi di scena risibili, nemmeno avvertiti come tali dal lettore smaliziato. Si concentra sui giochi di potere interni, su tinte lievi e giovanili, ma il lungo salto temporale aggiunge poco allo spaccato dell’inquietante Repubblica, meno ancora al mito della Atwood. A corto di scene memorabili o nuovi spunti di riflessione, elegantissima nello stile ma elementare nell’architettura, la lettura è parsa al di sotto delle aspettative e tutt’uno con la trasposizione televisiva: da qualche anno a questa parte in caduta libera, spiace constatarlo, dopo gli exploit della prima stagione – non a caso, riproposizione fedele del Racconto dell’ancella. Ci sono voluti trentacinque anni, pare, per svelarci l’ovvio. Prevedibilmente, il prosieguo della storia patisce una pianificazione a tavolino. Mancano le brutalità e l’urgenza, resta una scrittura tanto consapevole quanto compiaciuta: più forte ancora, però, è l’impressione che dietro la speculazione economica non ci sia sostanza. Pensavo fosse un testamento, invece era una fanfiction.