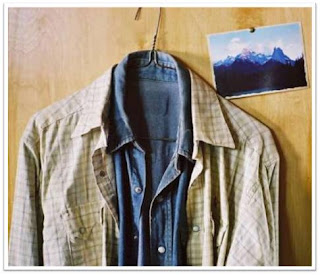Susan,
sofisticata gallerista, riceve un manoscritto inedito da Edward, il
primo marito. Lei borghese e lui senza il becco di un quattrino: tra i due, quando la ribellione aveva ceduto
il passo alla routine, non era finita bene. A ispirarle un impensato esame di coscienza,
a rubarle il riposo, quella lettura che la rabbonisce e la
schiaffeggia. Il dolce Edward la turba pagina dopo
pagina, con un'opera di cui non lo credeva capace: la
parabola violenta, disperata, di un uomo che persegue una lenta
vendetta. Animali Notturni è il ritorno di Tom Ford dopo lo struggente A Single
Man. A suo agio con le scarpe a specchio e i
divi senza un capello fuori posto, qui vuole stupire – e ci riesce,
anche se in definitiva gli ho preferito il più scontato
melodramma con Firth – con una storia nella storia. Animali
Notturni, coinvolgente thriller
allo specchio, si divide in due metà perfette e complementari:
costruito su piani narrativi opposti, alterna la realtà di Susan –
fredda, manierata, brillante come l'acciaio: e lì, in tutta la sua
eleganza, c'è il tocco del pioniere delle passerelle – alla
fantasia di Edward – al contario polverosa, sporca, selvatica. E,
ambizioso, il film è a due generi inconciliabili che guarda: il
languore del melodramma, così, viene stuprato dagli energumeni
sudici e logorroici del pulp di Tarantino. Tra passato e
presente, sparatorie e vernissage, Animali Notturni è
essenzialmente l'amara storia d'amore e vendetta di due vecchi amanti
– la magnifica Amy Adams, il tormentato Jake Gyllenhaal – che,
rancorosi ma presi, si tolgono il sonno a vicenda. Cos'è stato
dell'universitaria tanto disgustata dal perbenismo borghese? Cosa
dell'artista debole e bisognoso, ora artefice di parole come lame? Le
lunghe e soffocanti notti di Tom Ford non sono fatte per l'amore. Il
regista con il cognome da eroe western e lo sguardo dell'esteta,
cinico e sempre padrone di sé, bilancia le prove del suo cast di
fuoriclasse, gli opposti, le gradazioni di colore. La luna sussurra
un agghiacciante racconto pulp che, tra le righe, riassume vent'anni
di lontananza. E la scrittura, ammaliante e ragionata, onnipotente, è
un'arma che assicura finalmente l'ultima parola a chi – contro
Cupido e l'ipocrisia – una volta ha già perso. Quando ti
innamori di uno scrittore, dicono, vivi per sempre. E quando gli
spezzi il cuore? (7,5)
 Quanto
è bella Sarah Paulson: non ci avevo fatto caso. Quello il primo
pensiero, vedendola sorridere per la prima volta senza badare alla
dizione perfetta o alle rughe d'espressione. Meno manierata
che in passato, sciolta e confidente, mette in scena non un
personaggio ipercaratterizzato dei suoi: Amanda ha il suo stesso
viso, un marito molto più grande e, tornata nella città natale per
aiutare la sorella incinta, consacra un pomeriggio alle spese folli
per assecondare le voglie della parente. Tra le corsie del
supermercato incrocia il Jim di un sorprendente Mark
Duplass: al liceo erano innamorati pazzi, ma ventidue anni di silenzi
e lontananza li hanno trasformati. Lei, con un berretto che le
schiaccia i capelli e un giaccone trasandato, è tentata di volgere
lo sguardo altrove; lui è uscito di
casa senza radersi e lavarsi i denti. Ma loro invece si guardano e se lo domandano: com'è possibile
ritrovarsi lì, in quell'angolo di California in cui niente –
attempati cassieri compresi – è davvero cambiato? Possono fingersi
per una notte quelli di sempre, come se non ci si fossero messi di
mezzo matrimoni, amarezze e bivii raggirati? Blue Jay è un
poco galante invito a cena che nasconde, in realtà, una scusa:
viaggiare attraverso gli anni Novanta, dando man forte alle
musicassette e alla nostalgia, e ballare scordinati Annie Lennox
pestandosi le scarpe. Dramma indie prodotto da Netflix e
presentato in anteprima a Toronto, ha quel che cerco in una storia
d'amore da Prima dell'alba
in poi: lunghi dialoghi che fanno il bello e il cattivo tempo,
personaggi che trasformano le reciproche fragilità in vanto –
Amanda non sa piangere, mentre l'emotivo Jim
deve avere dimenticato come frenare le lacrime – e registi
discreti, che ci sono ma non si vedono. Blue Jay,
eppure, ha l'esordiente Alex Lehmann a dirigere, e la sua scelta è
ricaduta su intensi primi piani e uno struggente bianco e nero. Però
la splendida Paulson e il sensibile Duplass, protagonisti di una
magica sintonia, chiacchierano senza intralci – intorno a loro è
scomparsa la troupe, dev'essere finito anche il mondo – e si
abbandonano indisturbati ai ricordi. Maestri dell'improvvisazione, si
fingono marito e moglie con accenti posticci e languori che
scoppiano in sincere risate. Ma la loro buffa e agrodolce farsa è
più vera della realtà: più felice di sicuro. I grigi limpidi e i
sorrisi rubati per un soffio a Blue Jay stracciano
il cuore. E come dicono di una ballad di Adele che canta la gioventù perduta e seconde possibilità che spaventano, nel mentre puoi sentire perfino la nostalgia delle persone che non hai ancora amato. (8)
Quanto
è bella Sarah Paulson: non ci avevo fatto caso. Quello il primo
pensiero, vedendola sorridere per la prima volta senza badare alla
dizione perfetta o alle rughe d'espressione. Meno manierata
che in passato, sciolta e confidente, mette in scena non un
personaggio ipercaratterizzato dei suoi: Amanda ha il suo stesso
viso, un marito molto più grande e, tornata nella città natale per
aiutare la sorella incinta, consacra un pomeriggio alle spese folli
per assecondare le voglie della parente. Tra le corsie del
supermercato incrocia il Jim di un sorprendente Mark
Duplass: al liceo erano innamorati pazzi, ma ventidue anni di silenzi
e lontananza li hanno trasformati. Lei, con un berretto che le
schiaccia i capelli e un giaccone trasandato, è tentata di volgere
lo sguardo altrove; lui è uscito di
casa senza radersi e lavarsi i denti. Ma loro invece si guardano e se lo domandano: com'è possibile
ritrovarsi lì, in quell'angolo di California in cui niente –
attempati cassieri compresi – è davvero cambiato? Possono fingersi
per una notte quelli di sempre, come se non ci si fossero messi di
mezzo matrimoni, amarezze e bivii raggirati? Blue Jay è un
poco galante invito a cena che nasconde, in realtà, una scusa:
viaggiare attraverso gli anni Novanta, dando man forte alle
musicassette e alla nostalgia, e ballare scordinati Annie Lennox
pestandosi le scarpe. Dramma indie prodotto da Netflix e
presentato in anteprima a Toronto, ha quel che cerco in una storia
d'amore da Prima dell'alba
in poi: lunghi dialoghi che fanno il bello e il cattivo tempo,
personaggi che trasformano le reciproche fragilità in vanto –
Amanda non sa piangere, mentre l'emotivo Jim
deve avere dimenticato come frenare le lacrime – e registi
discreti, che ci sono ma non si vedono. Blue Jay,
eppure, ha l'esordiente Alex Lehmann a dirigere, e la sua scelta è
ricaduta su intensi primi piani e uno struggente bianco e nero. Però
la splendida Paulson e il sensibile Duplass, protagonisti di una
magica sintonia, chiacchierano senza intralci – intorno a loro è
scomparsa la troupe, dev'essere finito anche il mondo – e si
abbandonano indisturbati ai ricordi. Maestri dell'improvvisazione, si
fingono marito e moglie con accenti posticci e languori che
scoppiano in sincere risate. Ma la loro buffa e agrodolce farsa è
più vera della realtà: più felice di sicuro. I grigi limpidi e i
sorrisi rubati per un soffio a Blue Jay stracciano
il cuore. E come dicono di una ballad di Adele che canta la gioventù perduta e seconde possibilità che spaventano, nel mentre puoi sentire perfino la nostalgia delle persone che non hai ancora amato. (8)

C'è
chi, nei momenti di sconforto, nel freezer ci trova il gelato al
pistacchio. E chi, naufrago verso un pianeta da colonizzare, scongela
a piacimento una Jennifer Lawrence per combattere l'incontenibile
tristezza che affligge i passeggeri solitari. Jim si risveglia con novant'anni
d'anticipo. Il resto dell'equipaggio,
immerso in un sonno criogenico, continua a dormire. L'insonne condanna alla sua stessa sorte Aurora, sperando di proteggerla il più a lungo
possibile dalla verità. Futuristici Adamo ed Eva su una navicella
che cola a picco dopo il romantico idillio iniziale, Christ Pratt e
Jennifer Lawrence. Coppia tanto attraente quanto sopravvalutata, i
due riempiono il secondo film statunitense di Morten Tyldum di
ammiccamenti, litigi e occhiate poco convinte. A scatola chiusa,
eppure, Passengers sembrava
fantascienza seria. Distribuito nell'imminente stagione
dei premi sulla scia del fortunato The Imitation Game,
faceva il verso a Gravity con
la partecipazione dell'asso piglia tutto Jennifer Lawrence. Furbo e
attesissimo, il film prometteva odissee nello spazio e scintille: chi
non ha letto almeno una volta le dichiarazioni della protagonista,
brilla per combattere l'imbarazzo delle scene più spinte? Passengers
ha un sesso immaginario – a
qualcuno andrà forse meglio, con una visione passeggera del sedere
di Pratt – e una scrittura vittima del ridicolo involontario. Se l'ironia di lui
ispira empatia, l'assurda concitazione della Lawrence fa sì che la
nave (ogni riferimento a Titanic non
è causale) imbarchi altra acqua. Passengers altro
non è che una commedia superficiale nello spazio profondo. Da non
amante della fantascienza, non posso dire che la leggerezza della
traversata mi abbia annoiato. Le esplosioni delle
grandi produzione e le potenziali svolte tragiche, però, fanno sorridere. A
contendersi la colpa di questo blockbuster in avaria, lo
sceneggiatore e, a sorpresa, due divi colti impreparati dalle lunghe
e spontaee passeggiate dalle romcom che dico io. Con un bravissimo
Michael Sheen al bancone, automa loquace e pettegolo, si beve per
dimenticare le fotoricordo di una goffa e pacchiana crociera tra le
stelle. (5)

Rachel
affoga i dispiaceri in una bottiglia di chardonnay e, dal finestrino
del regionale, sbircia le vite altrui. Spia l'ex, felice accanto a
un'altra donna, e fantastica su una coppia sconosciuta che associa
alla perfezione. Viaggiando assiste a un tradimento che fa vacillare
le sue fiabe. E, svegliandosi da una notte di eccessi, insanguinata e
piena di lividi, scopre che Megan – la bionda tanto invidiata – è stata uccisa. Rachel ha
visto l'assassino in un momento di lucidità? O è lei, gelosa, a essersi macchiata del delitto? La trama la conoscete: è
quella del thriller più venduto da due anni a questa parte. La mia
opinione, forse, pure: un gonfiatissimo caso editoriale, criticato
per lo stile pedestre e il giallo intuibile. La ragazza del treno
era raffazzonato, intricato
invano. Una trasposizione poteva fare
solo meglio. Il film di Tate Taylor, stroncato dalla
critica, mi ha convinto il giusto, mostrandosi superiore al
romanzo della Hawkins – poco ci vuole, uno dice – e alle mie
scarse aspettative. La struttura tripartita resta, e insieme a quella
anche i difetti. Le voci narranti, il montaggio che prevede salti
indietro tutt'altro che pratici, il ritmo lontano da qualsiasi
frenesia si addicono poco alle esigenze del cinema di genere. Se il gioco non
vale la candela, se il mistero è modesto come in questo caso, il
puzzle di prospettive diverse – schematico ma originale –
giova. Se personaggi
maschili ridicolmente belli e sospetti fanno da corollario, allora, meglio le
donne: sprecata la Ferguson, annoiata moglie trofeo;
sorprendente la sexy Haley Bennett, irrequieta e sofferente
traditrice; in odore di nomination una farfugliante, stravolta Emily
Blunt. La ragazza del treno continua
a non avere i segreti
diabolici di Gone Girl,
ma i pensieri incensurati delle protagoniste lo avvicinano a un
dramma psicologico che, tra le righe, convince parlando di maternità
e relazioni. Tu togli una pessima scrittura e aggiungi un cast di
prime donne: così facendo, anche i prodotti più modesti non
escono fuori dai binari. (6,5)
 Si
può guarire dalla propria natura? Qualcuno pensa di sì. Lo pensa, forse, anche il protagonista: un ventenne vulnerabile e confuso, che della
sessualità ha conosciuto prima la violenza di un compagno di corso,
poi la tenerezza di un pittore con cui ha diviso il letto senza
spingersi oltre. Se sei omosessuale, se ti penti, puoi trovare
assoluzione. Spiace dirlo, ma non si tratta di un romanzo distopico.
Boy Erased, tratto dall'omonimo memoir letto lo scorso
novembre, è una storia realmente accaduta. Nel passaggio al cinema
sceglie toni crudi, iperrealistici, e un taglio a metà fra il documentario e il thriller d'inchiesta. Mosso da
sconvolgenti tensioni spirituali e sessuali, è una cronaca di
contrizione, di costrizione, approcciata con un distacco formale che
mi ha spiazzato in positivo. Hedges, afflitto e struggente, si
nasconde sotto una cappa di vergogna e senso di colpa con il
temperamento dei grandi attori. Notevolissimo, poco indulgente verso
personaggi e spettatori, Boy Erased va
incontro a una ribellione troppo precipitosa, a toni qui e lì troppo
freddi per paura di incappare nel pericolo didascalismo, ma tocca
riconoscergli meriti diffusi. Quella biografia indigesta su carta,
infatti, appariva inadattissima al cinema. I plausi spettano alla
recitazione minimalista del cast in gran completo, con i mattatori
della vecchia scuola e i nomi più glamour disposti a sparire in
ruoli di supporto. A Joel Edgerton, alla sua seconda prova da regista,
che adatta di proprio pugno e prende
in prestito le atmosfere asfissianti della sua opera prima. Si fanno
i conti con mamma Kidman e papà Crowe. Si
allunga la mano fuori per saggiare di cosa sappia la
libertà. Non si cancella la rabbia. (7)
Si
può guarire dalla propria natura? Qualcuno pensa di sì. Lo pensa, forse, anche il protagonista: un ventenne vulnerabile e confuso, che della
sessualità ha conosciuto prima la violenza di un compagno di corso,
poi la tenerezza di un pittore con cui ha diviso il letto senza
spingersi oltre. Se sei omosessuale, se ti penti, puoi trovare
assoluzione. Spiace dirlo, ma non si tratta di un romanzo distopico.
Boy Erased, tratto dall'omonimo memoir letto lo scorso
novembre, è una storia realmente accaduta. Nel passaggio al cinema
sceglie toni crudi, iperrealistici, e un taglio a metà fra il documentario e il thriller d'inchiesta. Mosso da
sconvolgenti tensioni spirituali e sessuali, è una cronaca di
contrizione, di costrizione, approcciata con un distacco formale che
mi ha spiazzato in positivo. Hedges, afflitto e struggente, si
nasconde sotto una cappa di vergogna e senso di colpa con il
temperamento dei grandi attori. Notevolissimo, poco indulgente verso
personaggi e spettatori, Boy Erased va
incontro a una ribellione troppo precipitosa, a toni qui e lì troppo
freddi per paura di incappare nel pericolo didascalismo, ma tocca
riconoscergli meriti diffusi. Quella biografia indigesta su carta,
infatti, appariva inadattissima al cinema. I plausi spettano alla
recitazione minimalista del cast in gran completo, con i mattatori
della vecchia scuola e i nomi più glamour disposti a sparire in
ruoli di supporto. A Joel Edgerton, alla sua seconda prova da regista,
che adatta di proprio pugno e prende
in prestito le atmosfere asfissianti della sua opera prima. Si fanno
i conti con mamma Kidman e papà Crowe. Si
allunga la mano fuori per saggiare di cosa sappia la
libertà. Non si cancella la rabbia. (7) Anche
i tossicodipendenti vogliono festeggiare il Natale in famiglia. Anche
a costo di confrontarsi con scie di cadaveri, speranze infrante e
parenti sconosciuti. Sempre nell'occhio del ciclone, nel mezzo delle
atmosfere nevose di Manchester by the sea,
riabbracciano fratelli e genitori, accarezzano il cane, ma portan guai. L'onnipresente Hedges, misuratissimo e in parte, fa i conti con
i suoi giovani crimini e con la mamma iperprotettiva di Julia
Roberts, a volte intensa e altre sopra le righe, che a momenti
alterni lo spalleggia e lo respinge. Da sinceramente toccante,
Ben is back si fa ansiogeno
nella seconda parte. Una ricerca porta a porta, nel peggio della
provincia americana, verso vie di fuga dall'incubo: peccato che i
risvolti criminosi, purtroppo, risultino posticci. Inseriti nella
sceneggiatura per aumentare le tragedie, le lacrime, l'ansia,
all'interno di una vicenda già complessa di per sé. Ambientato
nell'arco di una lunga giornata, il film di
Hedges padre è un viaggio nel lato oscuro delle festività,
ammorbidito dal carattere solare della protagonista e dai toni
indovinati dell'ora introduttiva. Difettoso ma coinvolgente, commovente senz'altro, resta uno di quei drammi che
hanno il coraggio di poggiarsi esclusivamente sui loro
interpreti, soltanto sulle emozioni che riescono a suscitare. Per
riportare i figli recidivi all'ovile e i kleenex, quelli
sperperati con gran mestiere, in sala. (6,5)
Anche
i tossicodipendenti vogliono festeggiare il Natale in famiglia. Anche
a costo di confrontarsi con scie di cadaveri, speranze infrante e
parenti sconosciuti. Sempre nell'occhio del ciclone, nel mezzo delle
atmosfere nevose di Manchester by the sea,
riabbracciano fratelli e genitori, accarezzano il cane, ma portan guai. L'onnipresente Hedges, misuratissimo e in parte, fa i conti con
i suoi giovani crimini e con la mamma iperprotettiva di Julia
Roberts, a volte intensa e altre sopra le righe, che a momenti
alterni lo spalleggia e lo respinge. Da sinceramente toccante,
Ben is back si fa ansiogeno
nella seconda parte. Una ricerca porta a porta, nel peggio della
provincia americana, verso vie di fuga dall'incubo: peccato che i
risvolti criminosi, purtroppo, risultino posticci. Inseriti nella
sceneggiatura per aumentare le tragedie, le lacrime, l'ansia,
all'interno di una vicenda già complessa di per sé. Ambientato
nell'arco di una lunga giornata, il film di
Hedges padre è un viaggio nel lato oscuro delle festività,
ammorbidito dal carattere solare della protagonista e dai toni
indovinati dell'ora introduttiva. Difettoso ma coinvolgente, commovente senz'altro, resta uno di quei drammi che
hanno il coraggio di poggiarsi esclusivamente sui loro
interpreti, soltanto sulle emozioni che riescono a suscitare. Per
riportare i figli recidivi all'ovile e i kleenex, quelli
sperperati con gran mestiere, in sala. (6,5) Si
sono spostati dove li hanno portati gli ingaggi di lui. Quando il lavoro è venuto meno, assieme all'amore, i bellissimi Mulligan e Gyllenhaal si sono dovuti improvvisare altro. Lei, civettuola e
vanitosa, dà lezioni di nuoto e lui, altezzoso al punto da rifuggire
la routine, seda incendi; il figlio parsimonioso, invece, fa da
aiutante in uno studio fotografico. La loro famiglia va in fumo
all'improvviso. Nella frustrante attesa che cada la neve, ci si
arrangia come si può. I divi hollywoodiani fanno i conti, così,
con il brusco risveglio dal sogno americano; con la fine di un
matrimonio felice. Le attenzioni, però, sono tutte per il silenzioso
testimone della loro relazione: un adolescente che apre a forza gli
occhi su un mondo di tradimenti e repressione, interpretato
dalla rivelazione Ed Oxenbould. Non tutto oro è quel che
luccica, no, a dispetto dei grandi nomi coinvolti, del best-seller di
Richard Ford alla base e dell'apprezzamento riscosso presso i festival giusti. Le pecche
di Wildlife, attesissimo
esordio alla macchina da presa di Paul Dano, ha i suoi maggiori
difetti in una scansione temporale confusa e in dialoghi quanto mai
ridondanti: la regia, consapevole ed elegante, incornicia sullo sfondo dei meravigliosi anni Cinquanta una Mulligan perfino più
insopportabile di quella vista nel Grande Gatsby.
Adattamento rigoroso e distaccato, scritto insieme alla compagna Zoe
Kazan, il dramma è un Revolutionary Road in
piccolo e visto da una piccola prospettiva, con una presa emotiva
minore del previsto e due personaggi troppo antipatici per suscitare alcuna empatia. Come la foto di un pallido dispiacere che, al
cinema, si è già fatta ricordo. (6,5)
Si
sono spostati dove li hanno portati gli ingaggi di lui. Quando il lavoro è venuto meno, assieme all'amore, i bellissimi Mulligan e Gyllenhaal si sono dovuti improvvisare altro. Lei, civettuola e
vanitosa, dà lezioni di nuoto e lui, altezzoso al punto da rifuggire
la routine, seda incendi; il figlio parsimonioso, invece, fa da
aiutante in uno studio fotografico. La loro famiglia va in fumo
all'improvviso. Nella frustrante attesa che cada la neve, ci si
arrangia come si può. I divi hollywoodiani fanno i conti, così,
con il brusco risveglio dal sogno americano; con la fine di un
matrimonio felice. Le attenzioni, però, sono tutte per il silenzioso
testimone della loro relazione: un adolescente che apre a forza gli
occhi su un mondo di tradimenti e repressione, interpretato
dalla rivelazione Ed Oxenbould. Non tutto oro è quel che
luccica, no, a dispetto dei grandi nomi coinvolti, del best-seller di
Richard Ford alla base e dell'apprezzamento riscosso presso i festival giusti. Le pecche
di Wildlife, attesissimo
esordio alla macchina da presa di Paul Dano, ha i suoi maggiori
difetti in una scansione temporale confusa e in dialoghi quanto mai
ridondanti: la regia, consapevole ed elegante, incornicia sullo sfondo dei meravigliosi anni Cinquanta una Mulligan perfino più
insopportabile di quella vista nel Grande Gatsby.
Adattamento rigoroso e distaccato, scritto insieme alla compagna Zoe
Kazan, il dramma è un Revolutionary Road in
piccolo e visto da una piccola prospettiva, con una presa emotiva
minore del previsto e due personaggi troppo antipatici per suscitare alcuna empatia. Come la foto di un pallido dispiacere che, al
cinema, si è già fatta ricordo. (6,5) I 4:3 del miglior cinema indipendente. La patina granulosa delle videocassette. L'approccio neorealista dei bambini secondo Sean Baker. Diciamolo: non ci si aspettava un esordio così da Jonah
Hill, ennesimo attore passato dall'altra parte. Famoso per la sua fisicità, per le commedie demenziali dei primi tempi a
cui sono seguite due insospettabili candidature agli Oscar,
l'interprete recentemente visto in Maniac raduna
una compagnia di birbanti per raccontarci l'infanzia
con i toni di Truffaut. Nocivi ma fondamentalmente buoni, talora dal
talento inespresso, i protagonisti introducono Stevie nella loro
cricca: ancora piccolo, con in casa una mamma single e un fratello
dispotico interpretato dal solito Hedges, vuole imparare ad andare
sullo skateboard. Per diventare
la mascotte dei grandi, mostrandosi impavido e sconsiderato, bisogna
approcciarsi anche alle droghe e al sesso. Da un lato Stevie ambisce
al perfetto equilibrio, per non disobbedire a mamma e per non
rompersi la testa. Dall'altro, invece, punta a luoghi fatti soprattutto per
gli afroamericani, per gli adulti. Come un Eight Grade più
distante da me per il linguaggio, l'approccio, il quartiere, Mid90s
racconta la formazione di un ragazzino troppo educato per la vita di
provincia, che in privato fa abuso di scuse e grazie. Colleziona amici e nemici,
si fa rispettare. E la sua diseducazione, fra frequentazioni
deleterie e momenti toccanti, è quella tipica di una generazione
perduta che sperava di andare lontano: magari su due ruote. Ma ha
confuso, purtroppo, il fine con il mezzo. La perdizione della
vita di strada, ritratta senza sporcature eccessive o presunzioni da
narratore impegnato, fa di questo esordio un film piccolo nel taglio e nelle
intenzioni, ma con tanta voglia di svelare con una sincerità e una limpidezza contagiose le ginocchia sbucciate dei suoi teneri anni. (7)
I 4:3 del miglior cinema indipendente. La patina granulosa delle videocassette. L'approccio neorealista dei bambini secondo Sean Baker. Diciamolo: non ci si aspettava un esordio così da Jonah
Hill, ennesimo attore passato dall'altra parte. Famoso per la sua fisicità, per le commedie demenziali dei primi tempi a
cui sono seguite due insospettabili candidature agli Oscar,
l'interprete recentemente visto in Maniac raduna
una compagnia di birbanti per raccontarci l'infanzia
con i toni di Truffaut. Nocivi ma fondamentalmente buoni, talora dal
talento inespresso, i protagonisti introducono Stevie nella loro
cricca: ancora piccolo, con in casa una mamma single e un fratello
dispotico interpretato dal solito Hedges, vuole imparare ad andare
sullo skateboard. Per diventare
la mascotte dei grandi, mostrandosi impavido e sconsiderato, bisogna
approcciarsi anche alle droghe e al sesso. Da un lato Stevie ambisce
al perfetto equilibrio, per non disobbedire a mamma e per non
rompersi la testa. Dall'altro, invece, punta a luoghi fatti soprattutto per
gli afroamericani, per gli adulti. Come un Eight Grade più
distante da me per il linguaggio, l'approccio, il quartiere, Mid90s
racconta la formazione di un ragazzino troppo educato per la vita di
provincia, che in privato fa abuso di scuse e grazie. Colleziona amici e nemici,
si fa rispettare. E la sua diseducazione, fra frequentazioni
deleterie e momenti toccanti, è quella tipica di una generazione
perduta che sperava di andare lontano: magari su due ruote. Ma ha
confuso, purtroppo, il fine con il mezzo. La perdizione della
vita di strada, ritratta senza sporcature eccessive o presunzioni da
narratore impegnato, fa di questo esordio un film piccolo nel taglio e nelle
intenzioni, ma con tanta voglia di svelare con una sincerità e una limpidezza contagiose le ginocchia sbucciate dei suoi teneri anni. (7) Sono
gli anni del Laureato e
Terminator. Di
Street Fighters nelle sale giochi. Thimotée Chalamet,
intrappolato nella sua sonnacchiosa città costiera, non appartiene né alla
schiera dei locali né a quella dei villeggianti. Emblema
dell'adolescente eternamente fuori posto, con bomboletta dell'asma in mano e un
corpo allampanato, si trova coinvolto suo malgrado in una
disavventura estiva che ha del paradossale, fra gente bellissima –
l'irraggiungibile Maika Monroe, il piantagrane Alex Roe – e droghe
leggere. Ma questo pesce piccolo sogna in grande: ha una
straordinaria propensione a mettersi nei guai e, per fare il salto,
spera di passare dall'erba alla cocaina. In un microcosmo di ragazze
fatali, spacciatori e colorati luna park, quanto è semplice pestare i
piedi alla gente sbagliata? Ennesima chicca targata A24, con un cast
di giovani talenti e la regia retrò di Elijah Bynum, Hot Summer
Nights sembra un po' una canzone di Lana Del Rey, un po' un
romanzo di John Green. Un narratore esterno ai fatti parla a nome
dell'intera città: i tre protagonisti, a detta sua, sono già
diventati un mistero. A sorpresa, così, i personaggi più
superficiali regalano attimi di struggimento e la svolta
drammatica, che nel finale imbocca i territori precipitosi e
serissimi del crime, gli dona più che a Ben is back:
Lascia, infatti, l'amaro in bocca e gli occhi tristi. Queste caldi
notti estive avevano proprio bisogno del refrigerio di un brivido,
pur di mostrarsi più che una toccata e fuga nel lato oscuro degli abusati '80s. (7)
Sono
gli anni del Laureato e
Terminator. Di
Street Fighters nelle sale giochi. Thimotée Chalamet,
intrappolato nella sua sonnacchiosa città costiera, non appartiene né alla
schiera dei locali né a quella dei villeggianti. Emblema
dell'adolescente eternamente fuori posto, con bomboletta dell'asma in mano e un
corpo allampanato, si trova coinvolto suo malgrado in una
disavventura estiva che ha del paradossale, fra gente bellissima –
l'irraggiungibile Maika Monroe, il piantagrane Alex Roe – e droghe
leggere. Ma questo pesce piccolo sogna in grande: ha una
straordinaria propensione a mettersi nei guai e, per fare il salto,
spera di passare dall'erba alla cocaina. In un microcosmo di ragazze
fatali, spacciatori e colorati luna park, quanto è semplice pestare i
piedi alla gente sbagliata? Ennesima chicca targata A24, con un cast
di giovani talenti e la regia retrò di Elijah Bynum, Hot Summer
Nights sembra un po' una canzone di Lana Del Rey, un po' un
romanzo di John Green. Un narratore esterno ai fatti parla a nome
dell'intera città: i tre protagonisti, a detta sua, sono già
diventati un mistero. A sorpresa, così, i personaggi più
superficiali regalano attimi di struggimento e la svolta
drammatica, che nel finale imbocca i territori precipitosi e
serissimi del crime, gli dona più che a Ben is back:
Lascia, infatti, l'amaro in bocca e gli occhi tristi. Queste caldi
notti estive avevano proprio bisogno del refrigerio di un brivido,
pur di mostrarsi più che una toccata e fuga nel lato oscuro degli abusati '80s. (7) Un'altra
identità da riformare. Un'altra sessualità negata. Questa volta
siamo nei primi anni Novanta, nei panni di una ragazza interrotta.
L'hanno beccata a pomiciare sui sedili posteriori con una compagna di
scuola e per lei hanno decretato una guarigione forzata in un centro
che mette al vaglio i sogni erotici che fa, la musica che ascolta, i
traumi pregressi e i fidanzatini del liceo. Con il rischio di perdere
sé stessa, di tradirsi, in nome di una religione a cui nessuno crede
fino in fondo e di una normalità predicata soltanto in teoria. I
toni sono quelli falsamente scanzonati di Noi siamo infinito.
Le ambientazioni ricordano gli istituti correttivi di Fino all'osso e Cinque giorni fuori. Inferiore ai titoli
citati, nonostante la delicatezza del tema, la discutibile vittoria
al Sundance e l'enorme talento di una fragile e focosa Moretz, La
diseducazione di Cameron Post racconta
una storia di ribellione e affermazione, ma non ha né anima né
originalità; colpi di testa o di cuore. L'esordio di Desiree Akhvan,
eppure inspiegabilmente ben accolto in patria, si lascia rabbonire e
semplificare, smussare. Troppo educato, titolo a parte, lascia che i
suoi protagonisti in terapia disegnino iceberg, per poi indugiare con profonda amarezza soltanto sulla superficie. (5,5)
Un'altra
identità da riformare. Un'altra sessualità negata. Questa volta
siamo nei primi anni Novanta, nei panni di una ragazza interrotta.
L'hanno beccata a pomiciare sui sedili posteriori con una compagna di
scuola e per lei hanno decretato una guarigione forzata in un centro
che mette al vaglio i sogni erotici che fa, la musica che ascolta, i
traumi pregressi e i fidanzatini del liceo. Con il rischio di perdere
sé stessa, di tradirsi, in nome di una religione a cui nessuno crede
fino in fondo e di una normalità predicata soltanto in teoria. I
toni sono quelli falsamente scanzonati di Noi siamo infinito.
Le ambientazioni ricordano gli istituti correttivi di Fino all'osso e Cinque giorni fuori. Inferiore ai titoli
citati, nonostante la delicatezza del tema, la discutibile vittoria
al Sundance e l'enorme talento di una fragile e focosa Moretz, La
diseducazione di Cameron Post racconta
una storia di ribellione e affermazione, ma non ha né anima né
originalità; colpi di testa o di cuore. L'esordio di Desiree Akhvan,
eppure inspiegabilmente ben accolto in patria, si lascia rabbonire e
semplificare, smussare. Troppo educato, titolo a parte, lascia che i
suoi protagonisti in terapia disegnino iceberg, per poi indugiare con profonda amarezza soltanto sulla superficie. (5,5)