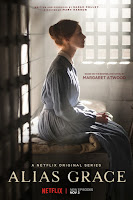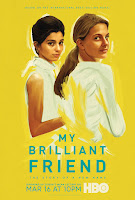 Se
non bastassero una sceneggiatura sopraffina, un cast scelto
attingendo a piene mani dall’immaginario dei lettori e una
ricostruzione storica curata nei minimi particolari, per suggerire la
grandezza della seconda stagione dell’Amica geniale potremmo
soffermarci su una scena della prima puntata: la sensibile Lenù,
immersa nella volgarità del rione, si accorge all’improvviso della
fine miserabile delle donne del quartiere; sfiorite paurosamente
appresso a mariti prevaricatori e figli a cui badare. Desidera forse
lo stesso per sé stessa? E per l’inseparabile Lila, costretta a
sposarsi? È una sequenza d’insieme magistrale, popolosa di
comparse e sottotesti, che lascia respirare aria da grande cinema
sulla TV generalista – si pensa a Martin Scorsese e Sergio Leone,
fino a omaggiare espressamente la Nouvelle Vague negli episodi
centrali diretti da Alice Rohrwacher. Perché la serie napoletana,
coprodotta da HBO e premiata dallo share, è un evento all’altezza
dei best-seller che traspone. Storia del nuovo cognome alza
l’asticella: è il romanzo che ho preferito della saga; le
protagoniste vivono gli alti e bassi dell’adolescenza, maturano; i
ribaltamenti sconvolgono spesso gli equilibri e le affinità. Stanno
al passo la regia di Costanzo, a tratti ariosa e a tratti sghemba
come un horror, e soprattutto gli interpreti. Il cast di attori
emergenti non si lascia spaventare né dalla violenza dei temi – la
prima notte di nozze di Lila è uno stupro brutale: un plauso
particolare spetta all’interprete di Stefano, Giovanni Amura, che
si sporca fino al midollo con un personaggio fragile ma spregevole –
né dalle lunghe sedute di trucco e parrucco che il prossimo anno, a
malincuore, non potranno far nulla per mascherare i soli diciassette
anni di Margherita Mazzucco (silenziosa e riflessiva, con uno sguardo
pieno di cose: un’eterna “quasi”) e Gaia Girace (struggente,
carismatica, selvaggia: ora incantevole, ora strega dal ghigno
beffardo). A causa di un importante salto temporale, come già
accaduto in The Crown, gli attori cambieranno. I nuovi
sapranno dare comunque un senso ai lunedì di Rai Uno, ormai sfitti?
Saranno altrettanto bravi a farsi amare e odiare, al punto da
spingere i social a commentare le puntate in tempo reale? Di ritorno da una vacanza indimenticabile, l’estate ischitana di Lenù e Lila è
giunta al termine; la loro adolescenza finisce qui. E la loro
amicizia singolare, fatta di supporto reciproco e competizione
irrefrenabile? Nel dubbio che attanaglia, per fortuna, restano le
foto ricordo di questi otto episodi da incorniciare. Li rivedremo e
ci commuoveremo, nell’attesa, come accade alla madre di Lenù –
Anna Rita Vitolo, straordinaria – davanti ai libri nuovi di quella
figlia maggiore che non capisce; in cui non credeva, proprio come noi
spettatori al debutto di questo gioiello. (8,5)
Se
non bastassero una sceneggiatura sopraffina, un cast scelto
attingendo a piene mani dall’immaginario dei lettori e una
ricostruzione storica curata nei minimi particolari, per suggerire la
grandezza della seconda stagione dell’Amica geniale potremmo
soffermarci su una scena della prima puntata: la sensibile Lenù,
immersa nella volgarità del rione, si accorge all’improvviso della
fine miserabile delle donne del quartiere; sfiorite paurosamente
appresso a mariti prevaricatori e figli a cui badare. Desidera forse
lo stesso per sé stessa? E per l’inseparabile Lila, costretta a
sposarsi? È una sequenza d’insieme magistrale, popolosa di
comparse e sottotesti, che lascia respirare aria da grande cinema
sulla TV generalista – si pensa a Martin Scorsese e Sergio Leone,
fino a omaggiare espressamente la Nouvelle Vague negli episodi
centrali diretti da Alice Rohrwacher. Perché la serie napoletana,
coprodotta da HBO e premiata dallo share, è un evento all’altezza
dei best-seller che traspone. Storia del nuovo cognome alza
l’asticella: è il romanzo che ho preferito della saga; le
protagoniste vivono gli alti e bassi dell’adolescenza, maturano; i
ribaltamenti sconvolgono spesso gli equilibri e le affinità. Stanno
al passo la regia di Costanzo, a tratti ariosa e a tratti sghemba
come un horror, e soprattutto gli interpreti. Il cast di attori
emergenti non si lascia spaventare né dalla violenza dei temi – la
prima notte di nozze di Lila è uno stupro brutale: un plauso
particolare spetta all’interprete di Stefano, Giovanni Amura, che
si sporca fino al midollo con un personaggio fragile ma spregevole –
né dalle lunghe sedute di trucco e parrucco che il prossimo anno, a
malincuore, non potranno far nulla per mascherare i soli diciassette
anni di Margherita Mazzucco (silenziosa e riflessiva, con uno sguardo
pieno di cose: un’eterna “quasi”) e Gaia Girace (struggente,
carismatica, selvaggia: ora incantevole, ora strega dal ghigno
beffardo). A causa di un importante salto temporale, come già
accaduto in The Crown, gli attori cambieranno. I nuovi
sapranno dare comunque un senso ai lunedì di Rai Uno, ormai sfitti?
Saranno altrettanto bravi a farsi amare e odiare, al punto da
spingere i social a commentare le puntate in tempo reale? Di ritorno da una vacanza indimenticabile, l’estate ischitana di Lenù e Lila è
giunta al termine; la loro adolescenza finisce qui. E la loro
amicizia singolare, fatta di supporto reciproco e competizione
irrefrenabile? Nel dubbio che attanaglia, per fortuna, restano le
foto ricordo di questi otto episodi da incorniciare. Li rivedremo e
ci commuoveremo, nell’attesa, come accade alla madre di Lenù –
Anna Rita Vitolo, straordinaria – davanti ai libri nuovi di quella
figlia maggiore che non capisce; in cui non credeva, proprio come noi
spettatori al debutto di questo gioiello. (8,5)
Lo
spunto è di quelli brillantissimi. Uno colpo di scena degno
del cinema di Shyamalan, piazzato però volutamente in apertura di
serie. I protagonisti di The Good Place – comedy
fortunatissima, apprezzata da pubblico e critica, e terminata
quest’anno dopo quattro stagioni – sono tutti morti. Affiancati
da un’anima gemella, popolano un distretto ridente e colorato
guidato dal saggio Michael: un architetto celeste dai papillon a
fantasia, con un’esilarante tuttofare – Janet, il personaggio più
iconico tra tutti – e il vizio di prendersi troppo a cuore i
problemi degli umani. Nella parte buona tutto è possibile. Anche
perdonare qualcuno come la peperina Kristen Bell, che in vita ha
collezionato peccati grandi e piccoli e lassù ci è finita per un
errore del sistema? Circondata da anime pie, la protagonista a
lezione di moralità farà di tutto per mimetizzarsi. Ma il lato
oscuro la tenterà fino all’ultimo, rischiando di mettere a
soqquadro un paradiso molto diverso dal cliché che ci hanno
insegnato al catechismo. L’ereditiera dall’accento inglese
Tahani, il professore scrupoloso Chidi e l’imprevedibile Jason,
monaco buddista che ha fatto voto di silenzio, meritano forse più di
lei una seconda chance? Centellinata in poco più di un mese, questa
serie – snobbata ai tempi dell’esordio – è una sorpresa
instancabile. Cambiano in fretta i ruoli di potere, gli scenari, i
punti di vista, gli obbiettivi da raggiungere: al punto che è
difficile parlarvene senza dire troppo. Il finale della prima
stagione, in particolare, vi lascerà a bocca aperta davanti a un
twist degno di Lost. Certo, non è tutto oro quel che luccica;
i difetti abbondano. Ad esempio gli si rimprovera un andamento un po’
monotono, fatto di continui andirivieni, o la relazione poco sentita
tra due dei protagonisti. Perciò che via vai sia, sì, purché
sullo sfondo di una mitologia accurata e ricca d’inventiva; su un
green screen che qualche volta fa storcere il naso e qualche volta
sorprende quando dirige Drew Goddard. Si ride tanto, ci si affeziona
alle lotte dei protagonisti, ci si stupisce e si riflette. Chi merita
davvero l’espiazione? Il male che abbiamo fatto può cadere in
prescrizione? Perfino la perfezione assoluta, a lungo andare, può
rivelarsi una gabbia soffocante? Per fortuna c’è sempre una
giudice clemente, un cavillo tecnico, un’altra porta da varcare,
per salvarci tutti dai proverbiali guai in paradiso. Cos’è la
morte allora: una tragedia o il principio del lieto fine? (7)