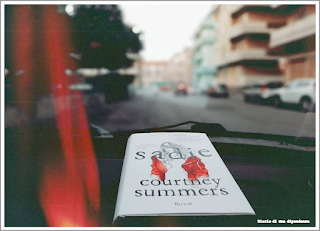Quando
l'horror divide mi sono sempre trovato a far parte della schiera
degli estimatori. Così è accaduto anche per Hereditary,
tragedia mascherata da ghost
story.
Per far capire la differenza con il nuovo film del regista, retto
nuovamente da una protagonista sull'orlo di una crisi di nervi, descriverò la
reazione della sala davanti a una scena che si ripresenza, a un
assordante urlo di donna: se quello della Collette ammutoliva, quello
della Pugh ha scatenato al cinema grasse risate. Colpa di una brutta
interpretazione da parte dell'interprete di Lady Macbeth,
o forse di compagni di visione troppo rumorosi? La colpa, in realtà,
spetta a un horror ambizioso e provante, che flirta con i toni
camp rovinando la nostra percezione complessiva. La trama, né
più né meno di quella di un found
footage del
decennio passato: una cinepanettonesca comitiva di studenti, in cerca
di sballo e sesso, punta alla Svezia con la scusa della tesi. Come se
non bastasse la presenza della lacrimosa fidanzata del
protagonista, unica sopravvissuta al suicidio dell'intera famiglia, a
rovinare i piani saranno anche gli abitanti di un'inquietante comune.
A canti folkloristici, rune e riti corrisponderanno di pari passo
orge, suicidi e roghi. Midsommar
è tutto
girato alla luce del sole. La fotografia, incantevole, risulta
abbacinante e cupissima. Quel cielo troppo azzurro disorienta, tanto
quanto gli espedienti al confine col trash per rendere i
turisti parte della comunità. Il teen horror cita
Hereditary,
riprendendone i culti esoterici – la parte peggiore del
film precedente – e la pesantezza inusitata. Il rischio: dare
eccessiva importanza a personaggi immaturi, a dettagli
impercettibili, che nel finale caricano la pellicola di un enfasi incomprensibile. Non si parla della morte scioccante di un figlio,
infatti, bensì di due ventenni spaventati da un amore finito.
Servivano 140 minuti per venirne a capo? Serviva l'ennesimo
film sull'orgoglio femminile – la morale, ebbene sì, lì va a parare –, con sprezzo del ridicolo aggiunto? Sempre geometrico
e perturbate, con una poetica che al secondo lungometraggio già
inizia a sembrare ripetitiva, Aster firma un ritorno sopravvalutato
ma dal fascino inconfutabile. Una natura morta rubata al puntinismo
di Seurat, che brucia nel falò della sua stessa vanità. Svegliandoci a metà di
ques'incubo di una notte di mezza estate. (5,5)
Lui
è un ragazzo di campagna, scrittore aspirante. Lei, ex compagna di
scuola inconsapevolmente seducente, è la storia di una
notte e via. L'altro, novello Jay Gatsby, è ricchissimo e sospetto:
soprattutto quando la ragazza, al centro di un triangolo degno del
cinema francese, scompare nel nulla. Burning,
ispirato a un racconto di Murakami, è un melodramma a tinte gialle
tanto conturbante quanto difficile da scomporre. Gli atteggiamenti sconnessi
dei protagonisti, i ritmi dilatati fino allo spasimo e quel finale
sfuggente, intessuto di falsi ricordi e inquietanti fantasie
masturbatorie, sono oggetto fino all'ultimo dell'interpretazione di
ciascuno. Per quanto non abbia mai fatto miei gli enigmi del giovane
protagonista – silenzioso e monoespressivo, lontano da me per
lingua e cultura – sono rimasto folgorato dalle danze in topless
sulla colonna sonora jazz, dalle sessioni di jogging sugli sfondi di
una fotografia meravigliosa, dall'istinto piromane dei protagonisti.
Qualcuno ha bruciato i vestiti della madre traditrice, qualcun altro
arde invece granai periodicamente. Cosa rappresenta la ricerca dei
suddetti? Che fine ha fatto la ragazza scomparsa? Perché quel finale
tragico e precipitoso, dopo la flemma del resto? Si parla di
conflitti di classe. Di ventenni belle e annoiate, solitarie come
serre in stato d'abbandono, che cercano loro stesse nei viaggi, nelle
droghe, nel mistero. Se sparissero, chi le cercherebbe? Buring
brucia
lentamente, senza vampate e senza calore. Ma forse non si esaurisce
qui. Come il sapore di un'arancia immaginaria che la protagonista,
esperta di pantomima, sbuccia e pilucca a piacere, consapevole del
confine fra vuoto e presenza. (7)
 Dopo
aver rivoluzionato il genere vampiresco nell'era consacrata a Twilight, l'autore svedese di Lasciami entrare torna
a regalarci un'altra gemma gotica d'amore e diversità. Questa volta i
protagonisti non sono due bambini: bruttissimi a
vedersi, piuttosto, attirano occhiate stranite per il loro aspetto esteriore. Non soltanto deforme ma dotata di un utile sesto senso – un
fiuto eccezionale –, Tina lavora alla dogana fiutando in anticipo
cattive intenzioni: che siano droghe o materiale pedopornografico,
non le sfugge niente. Fino a quando, lei che è tanto abile a fiutare
l'odore delle bugie, non incrocia un altro della stessa specie.
Complementari, hanno paura dei fulmini, un'apparente malformazione
cromosomica e le stesse cicatrici. Vore, che ammansisce gli animali
con uno sguardo ed è un tuttuno con la natura, la invita a
correre nuda nei boschi, a banchettare con i vermi: a mettere in
discussione la propria origine. Nel mentre, ci regaleranno la visione
di uno degli amplessi più strani e affascinanti che vedremo mai:
tutto grugniti, ansiti e denti, con tanto di bizzarri genitali
adocchiati di fretta, riassume alla perfezione lo spirito di Border.
Quanto splendore c'è in quella bruttezza? Suggestiva leggenda nordica che attinge a
piene mani nella mitologia nord-europea, il film è una storia di
autoaffermazione e moderni troll che mescola la cronaca nera al fascino
dell'inconsueto. Poetico ma ammantato di una grezza patina realistica
– ho ripensato al nostro Lazzaro Felice
–, regala brividi impensati e immagini che sfido a dimenticare.
Cosa separa il bene dal male? Le creature di Border
vengono sorprese mentre si muovono lì, a confine, e decidono da che
parte della barricata schierarsi; se restare umani o diventare
mostri, tutto per amore. (8)
Dopo
aver rivoluzionato il genere vampiresco nell'era consacrata a Twilight, l'autore svedese di Lasciami entrare torna
a regalarci un'altra gemma gotica d'amore e diversità. Questa volta i
protagonisti non sono due bambini: bruttissimi a
vedersi, piuttosto, attirano occhiate stranite per il loro aspetto esteriore. Non soltanto deforme ma dotata di un utile sesto senso – un
fiuto eccezionale –, Tina lavora alla dogana fiutando in anticipo
cattive intenzioni: che siano droghe o materiale pedopornografico,
non le sfugge niente. Fino a quando, lei che è tanto abile a fiutare
l'odore delle bugie, non incrocia un altro della stessa specie.
Complementari, hanno paura dei fulmini, un'apparente malformazione
cromosomica e le stesse cicatrici. Vore, che ammansisce gli animali
con uno sguardo ed è un tuttuno con la natura, la invita a
correre nuda nei boschi, a banchettare con i vermi: a mettere in
discussione la propria origine. Nel mentre, ci regaleranno la visione
di uno degli amplessi più strani e affascinanti che vedremo mai:
tutto grugniti, ansiti e denti, con tanto di bizzarri genitali
adocchiati di fretta, riassume alla perfezione lo spirito di Border.
Quanto splendore c'è in quella bruttezza? Suggestiva leggenda nordica che attinge a
piene mani nella mitologia nord-europea, il film è una storia di
autoaffermazione e moderni troll che mescola la cronaca nera al fascino
dell'inconsueto. Poetico ma ammantato di una grezza patina realistica
– ho ripensato al nostro Lazzaro Felice
–, regala brividi impensati e immagini che sfido a dimenticare.
Cosa separa il bene dal male? Le creature di Border
vengono sorprese mentre si muovono lì, a confine, e decidono da che
parte della barricata schierarsi; se restare umani o diventare
mostri, tutto per amore. (8) Bionda,
alta, bellissima, è un incrocio fra Lily James ed
Elle Fanning. Un corpo statuario e, sotto le fasciature, un segreto a
cui porre rimedio. Nata in un corpo maschile, Lara fa i conti con una
doppia difficolà: farsi strada in una scuola di danza di cui forse
non è all'altezza; diventare donna. Talentuosa ma non abbastanza
tecnica, graziosa ma non abbastanza femmina, come se la caverà fra
ballerini d'alto livello e nell'universo delle donne? Non paga del
sostegno di un papà dolcissimo, la protagonista vive una prigionia
la cui fine non è mai vicina a sufficienza. Allora ha fretta: vorrebbe saltare le
attese, le visite, e anche l'adolescenza. S'impunta, sulle
punte, ma i traguardi si allontanano anziché avvicinarsi. Senza
grandi gesti di bullismo né parole di intolleranza,
scabroso ma mai gratuito, Girl è
il romanzo di formazione di una ragazza a metà con una nuova casa,
una nuova scuola, una nuova sé. Il regista – classe 1991 –
sfoggia un tocco così delicato da rendere universali i sentimenti
della ballerina. La visione, meno pesante del previsto, altro non è
che un tuffo nei turbamenti dell'adolescenza visti da una
prospettiva, all'inizio, diversa soltanto in teoria. C'è sofferenza
nella routine di lei, ma anche tanta bellezza, gioia, sollievo. Sarà
per questo che il finale, seppure speranzoso, giunge tanto doloroso
da spingere a coprirsi gli occhi in poltrona? Perché l'adolescenza è
un sentimento universale, la protagonista è tale e quale a come
siamo stati noi alla sua età, ma alcune sofferenze restano
inimmaginabili. Grazie alla grandezza di un certo cinema, per
fortuna, non inviolabili. (7,5)
Bionda,
alta, bellissima, è un incrocio fra Lily James ed
Elle Fanning. Un corpo statuario e, sotto le fasciature, un segreto a
cui porre rimedio. Nata in un corpo maschile, Lara fa i conti con una
doppia difficolà: farsi strada in una scuola di danza di cui forse
non è all'altezza; diventare donna. Talentuosa ma non abbastanza
tecnica, graziosa ma non abbastanza femmina, come se la caverà fra
ballerini d'alto livello e nell'universo delle donne? Non paga del
sostegno di un papà dolcissimo, la protagonista vive una prigionia
la cui fine non è mai vicina a sufficienza. Allora ha fretta: vorrebbe saltare le
attese, le visite, e anche l'adolescenza. S'impunta, sulle
punte, ma i traguardi si allontanano anziché avvicinarsi. Senza
grandi gesti di bullismo né parole di intolleranza,
scabroso ma mai gratuito, Girl è
il romanzo di formazione di una ragazza a metà con una nuova casa,
una nuova scuola, una nuova sé. Il regista – classe 1991 –
sfoggia un tocco così delicato da rendere universali i sentimenti
della ballerina. La visione, meno pesante del previsto, altro non è
che un tuffo nei turbamenti dell'adolescenza visti da una
prospettiva, all'inizio, diversa soltanto in teoria. C'è sofferenza
nella routine di lei, ma anche tanta bellezza, gioia, sollievo. Sarà
per questo che il finale, seppure speranzoso, giunge tanto doloroso
da spingere a coprirsi gli occhi in poltrona? Perché l'adolescenza è
un sentimento universale, la protagonista è tale e quale a come
siamo stati noi alla sua età, ma alcune sofferenze restano
inimmaginabili. Grazie alla grandezza di un certo cinema, per
fortuna, non inviolabili. (7,5) Un'altra
ragazza che cambia corpo e città. Un'altra vicenda di maturazione
fisica e psicologica sullo sfondo di una rivoluzione epocale: quella
di un corpo che cambia con l'arrivo del ciclo mestruale. Mia, sedici
anni, si sente strana. Colpa delle sigarette, delle droghe, dei furti
e del sesso selvaggio, che la lasciano a smaltire incubi e
doposbornia. Colpa di un'indole che si risveglia, e la spinge a
commettere atti di crudeltà verso persone e animali, pesci rossi
soprattutto; a nutrire una destabilizzante voracità sessuale. Blue
my mind, notato per il titolo
bellissimo e per il ritardo nella distribuzione – in Svizzera,
infatti, è uscito ben due anni fa –, sceglie un nuovo elemento –
l'acqua – per raccontare il passaggio dall'adolescenza
all'età adulta. I riti di iniziazione: la classica cricca di cattive
ragazze presso cui farsi ammettere; un'amicizia a tinte saffiche che
porta a fondo con sé risposte e misteri, ma nel mentre intriga
grazie a una mitologia dosata con cura e al realismo degli effetti
visivi. Ritratto giovanilistico nello stile di Sofia Coppola, con una
splendida protagonista che ricorda la Johansson degli esordi,
sconfina infine nel body horror:
peccato che dopo l'ennesimo festino rumoroso, dopo l'ennesimo
squallido amplesso di gruppo degno della pagina più pruriginosa di Melissa P.,
la visione venga a nausea per i motivi sbagliati. Presentissime
l'inquietudine e la confusione, intelligente la metafora acquatica.
Ma foto promozionali e recensioni, purtroppo, rovinano in anticipo
l'effetto sorpresa preannunciando la deriva finale – e frenandone,
quindi, l'onda d'urto. (6,5)
Un'altra
ragazza che cambia corpo e città. Un'altra vicenda di maturazione
fisica e psicologica sullo sfondo di una rivoluzione epocale: quella
di un corpo che cambia con l'arrivo del ciclo mestruale. Mia, sedici
anni, si sente strana. Colpa delle sigarette, delle droghe, dei furti
e del sesso selvaggio, che la lasciano a smaltire incubi e
doposbornia. Colpa di un'indole che si risveglia, e la spinge a
commettere atti di crudeltà verso persone e animali, pesci rossi
soprattutto; a nutrire una destabilizzante voracità sessuale. Blue
my mind, notato per il titolo
bellissimo e per il ritardo nella distribuzione – in Svizzera,
infatti, è uscito ben due anni fa –, sceglie un nuovo elemento –
l'acqua – per raccontare il passaggio dall'adolescenza
all'età adulta. I riti di iniziazione: la classica cricca di cattive
ragazze presso cui farsi ammettere; un'amicizia a tinte saffiche che
porta a fondo con sé risposte e misteri, ma nel mentre intriga
grazie a una mitologia dosata con cura e al realismo degli effetti
visivi. Ritratto giovanilistico nello stile di Sofia Coppola, con una
splendida protagonista che ricorda la Johansson degli esordi,
sconfina infine nel body horror:
peccato che dopo l'ennesimo festino rumoroso, dopo l'ennesimo
squallido amplesso di gruppo degno della pagina più pruriginosa di Melissa P.,
la visione venga a nausea per i motivi sbagliati. Presentissime
l'inquietudine e la confusione, intelligente la metafora acquatica.
Ma foto promozionali e recensioni, purtroppo, rovinano in anticipo
l'effetto sorpresa preannunciando la deriva finale – e frenandone,
quindi, l'onda d'urto. (6,5) Avvertenze
prima della visione: il film che segue, in ordine sparso, riporta
parole di omofobia, transfobia e sessismo; mostra consumo di alcol, stupefacenti e
materiale pornografico; sfocia nell'epilogo in un esilarante bagno di sangue.
Nella Salem dei giorni nostri si consuma una novella caccia alle
streghe dalle immancabili tinte politiche, al tempo dei nudi
hackerati e della presidenza Trump. Prima il sindaco, poi il preside finiscono nella rete dello scandalo. Ma ben presto il pirata informatico colpisce
l'intera cittadina – online: foto, video, segreti sbandierati –, e
capro espiatorio diventa una studentezza con la fama di sfasciafamiglie. Può l'intera popolazione scagliarsi contro una
diciottenne e la sua cricca di amcihe? Commedia adolescenziale a metà fra
Schegge di follia
e La notte del giudizio,
l'irresistibile Assassination
Nation è
l'ultima succulenta frontiera dell'home invasion dove l'unione fa la
forza. Ritratto dei Millennials tanto impietoso quanto stiloso,
va recuperato da coloro che in queste settimane stanno ammirando sul
piccolo schermo la regia straordinaria di Euphoria:
Levinson, figlio d'arte, era un fuoriclasse
già ai tempi del suo esordio cinematografico. Se i temi sono simili a quelli poi
approfonditi con la serie HBO, chi non vorrebbe vederlo alle prese
con i giochi di luci e ombre del miglior Carpenter o le spose assassine di
Tarantino? Da recuperare, insomma: per rifarsi gli occhi e le coscienze. (7)
Avvertenze
prima della visione: il film che segue, in ordine sparso, riporta
parole di omofobia, transfobia e sessismo; mostra consumo di alcol, stupefacenti e
materiale pornografico; sfocia nell'epilogo in un esilarante bagno di sangue.
Nella Salem dei giorni nostri si consuma una novella caccia alle
streghe dalle immancabili tinte politiche, al tempo dei nudi
hackerati e della presidenza Trump. Prima il sindaco, poi il preside finiscono nella rete dello scandalo. Ma ben presto il pirata informatico colpisce
l'intera cittadina – online: foto, video, segreti sbandierati –, e
capro espiatorio diventa una studentezza con la fama di sfasciafamiglie. Può l'intera popolazione scagliarsi contro una
diciottenne e la sua cricca di amcihe? Commedia adolescenziale a metà fra
Schegge di follia
e La notte del giudizio,
l'irresistibile Assassination
Nation è
l'ultima succulenta frontiera dell'home invasion dove l'unione fa la
forza. Ritratto dei Millennials tanto impietoso quanto stiloso,
va recuperato da coloro che in queste settimane stanno ammirando sul
piccolo schermo la regia straordinaria di Euphoria:
Levinson, figlio d'arte, era un fuoriclasse
già ai tempi del suo esordio cinematografico. Se i temi sono simili a quelli poi
approfonditi con la serie HBO, chi non vorrebbe vederlo alle prese
con i giochi di luci e ombre del miglior Carpenter o le spose assassine di
Tarantino? Da recuperare, insomma: per rifarsi gli occhi e le coscienze. (7)