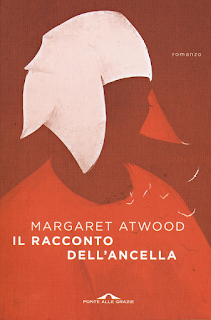| Tempi duri per i romantici, Tommaso Fusari. Mondadori, € 16, pp. 204 |
Quando
la mia amica Laura mi ha intimato di dare una possibilità
all'esordio di Tommaso Fusari, mi ha colto impreparato e scettico. Ti
piace, assicurava, e sembrava non aver dubbi. Ho messo
l'ebook sul Kindle tanto per, un giorno, timoroso di dare un
dispiacere a lei – quando consiglio spassionatamente un romanzo e
non lo amano altrettanto, mamma mia che presa a male – e a Tommaso, autore
che non conosco né di fama né di persona ma con cui empatizzo per
via della barba, i vent'anni e la lenta agonia dell'amore romantico.
Noi giovani siamo i peggiori nemici di noi stessi. Quelli di se ce
l'ha fatta lui perché io no. Le smanie per dimostrarci adulti
abbastanza, i profili falsi, il pollice verso agli Youtuber –
categorie di cui ho scarsa stima, lo ammetto, come ogni pensionato
intrappolato nel corpo di un ventritreenne che si rispetti. Storco il
naso davanti alle massime post Tumblr, agli instascrittori. Nel caso
di Fusari, balzato all'occhio della Mondadori a suon di hashtag,
temevo una trama per finta e frasi tattiche per Mi
piace assicurati. Tempi duri per i romantici è
diventato uno di quei romanzi brevi, sulle duecento pagine, che
sfoglio in attesa che venga a citofonarmi il corriere. Il corriere
non è passato e, in un paio di sere, perciò l'ho letto. A volte, sai, le sorprese delle letture fuori programma... Mi è
piaciuto, tocca non tenere la Libridinosa sulle spine, perché ci sono quei
romanzi imperfetti e un po' furbi a cui vuoi bene comunque – qui, oggettivamente, troppi eserciti e terroristi fermati con una sola occhiata, tanti
titoli da riempirci le pagine e le playlist, molte scene leitmotiv.
La trama c'è: dieci anni di lontananza, una questione in sospeso, un
viaggio per capire cosa si è rotto e quando. Stefano, commesso in un
negozio di abbigliamento a Roma, ha un monolocale zeppo di
amici alla mano, il pallino delle battutacce e una ragazza che non
ama. Aspetta quella giusta, infatti, e l'ha perfino conosciuta. Erano
bambini, dirimpettai, e facevano la stessa strada per andare a
scuola.
Due
destini paralleli con lo sguardo basso e le mani in tasca.
Andandosene
all'improvviso, Alice ha portato con sé il sogno di una casa a picco
sul mare, un cornicione tinteggiato di rosa shocking e le costellazioni delle
sue lentiggini. Cos'è stato di lei, che gli tirava trucioli
di pellet alla finestra e prometteva di aspettarlo di ritorno dalle
vacanze estive? Il mistero di un'amica scomparsa nell'indifferenza
spinge a un biglietto di solo andata per Torino; all'amara scoperta
che, in mezzo a loro, ci è cresciuto un mare. E se non gli piacesse
quel che è diventata? E se partire significasse ritornare? Alice
resta bellissima: bellissima con in Dante, bellissima da far
incazzare gli angeli e trionfare la pace in Medio-Oriente. Si è
bruciata, però, coi suoi capelli di fuoco. Lui spegne l'incendio e
la ripulisce dalla polvere. Vorrebbe guarirla, standole alle costole
– e le schifezze mangiucchiate sotto un plaid, la testa dura e le
compagnie che riempiono le ore piccole pure fanno la loro parte.
Hanno tanto tempo da recuperare e un sentimento in pausa. In Tempi
duri per i romantici si ritorna
sui luoghi di un colpo di fulmine e, come diceva Ewan McGregor in Big
Fish, il tempo scorre a velocità
doppia. Fusari ha un narratore con la memoria da elefante e il passo
veloce; una coprotagonista che c'è, dappertutto, anche quando manca.
“Quando
sarò grande farò il giro del modo” afferma Alice improvvisamente.
“Se
fai il giro vuol dire che poi tornerai qui.”
“Non
mi piace tanto qui.”
“Allora
torni a prendermi e ripartiamo?”
Ha
uno sguardo che piace: la realtà, opaca come una foto venuta male, è
messa a fuoco a parole, e qualche dettaglio colpisce più di altri –
bello il capitolo ambientato in stazione, in cui si ragiona di
abbracci lunghi, arrivi e partenze (se cercassi bene, probabilmente,
su una panchina di cemento ci sarei anche io, che al solito aspetto e spero). Fusari ha il sorriso
facile, i jeans informali, bella musica in macchina, il frigorifero
sempre pieno – l'ho sentito,
e ho sentito che ci andrei d'accordo, tra un sorso di birra e un tiro
a scrocco, non solo per le dispute in merito all'amatriciana perfetta
(Tommaso, sono della tua stessa scuola di pensiero: pomodorini, senza
soffritto, tanto pepe). Riflessivo e paziente, dopo le sorprese
altrettanto gradite di Galiano e Mandetta, emoziona con temi e
sentimenti che, dice eppure il cliché, sono cosa da femmine o d'altre
epoche. Sensibile alla maniera dei maschi – che si affezionano
prima e di più, che non dicono mai davvero addio –, Tempi
duri per i romantici si imbatte
nel destino agrodolce di una razza in via d'estinzione. Una canna in balcone, la
pancia piena e il ritrovarsi dopo un intero decennio ispirano pensieri che
parlano di amori per sempre, Torino senza polenta e altri
luoghi impossibili. Il puzzle di Stefano e Alice, che ha sulla scatola una coppia, un'infanzia e un altro po', è finalmente completo. Ci si vede presto, e presto è già qui.
Il
mio voto: ★★★★
Il
mio consiglio musicale: I Cani – Il posto più freddo