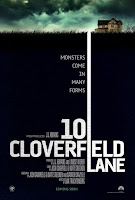Non sentivo un
film da mesi. Non cominciavo così da un po'. Trovo confortante,
perciò, dirvi che si parte di nuovo da qui: come piace a me. Ragazzo conosce ragazza. Paolo, orfano pavido e bisognoso, si è perso
in mezzo alle luci stroboscopiche di un locale gay: cerca di
scongiurare il suo compagno affinché gli dia una seconda chance. Mia, volitiva sin dal nome, è
al sesto mese di gravidanza: ha bevuto troppo, si accascia tra le braccia di lui. Che è un
gigante buono dagli occhi tristissimi e, per carattere, non sa dire di no. Quella Madonnina con i tatuaggi e i capelli rosa lo
prende per mano e lo trascina a 1300 chilometri di distanza. Da
copione, ci si innamora o quasi nel mentre. Al centro: le chiacchiere
e le liti, le tappe che nessuno avrebbe immaginato. Alla
fine: una chiusa agrodolce, di quelle che se è la sera giusta sanno commuovere. Il
padre d'Italia è un dramma su ruote con un po' di Away We Go, un po'
di Una giornata particolare e tanta bellezza. Introspettivo, intimo, parlato a lungo, pone al
centro i suoi personaggi – caratterizzati con cura e pazienza,
vicini a me –, e la regia sincronizza di conseguenza il suo passo
al loro. L'irruenza della Ragonese e i silenzi carichi di Marinelli
(magnifico, e con un altro personaggio, dopo il memorabile Guido di Tutti
i santi i giorni, in cui ci sono i miei stessi punti di saturazione) chiamano a sé gli Smiths e la Bertè canticchiati piano, le lunghe carrellate e i personaggi di spalle, le ipnotiche luci al neon del cinema di Dolan. Mollo ha
lo sguardo indie che piace; l'alchimia di due che quei personaggi
intensissimi sanno portarli in vita con un gesto; lo sfondo in
movimento di un'Italia bigotta, con etichette che affibbiano sensi di colpa perfino all'amore. Paolo, troppo cerebrale di
suo, ne è pieno. E' contro natura che uno come lui diventi
genitore? E' contro natura, dopo la sofferta convivenza con un uomo, prendersi cura di una sciagurata che sfida il mare col petto in fuori e, a letto, gli ricorda quanto è caldo un altro corpo? Il liquido amniotico restituisce l'illusione di una
seconda infanzia; le donne insegnano a galleggiare. Il padre
d'Italia preferisce parlare d'appartenenza e istinto, senza sollevare polveroni. Di miracoli che, nella mano grinzosa
di una figlia, fanno riaffiorare il volto di una madre. Dell'emozione di sbagliare strada, scoprendosi lo stesso a casa. (7,5)
Non sentivo un
film da mesi. Non cominciavo così da un po'. Trovo confortante,
perciò, dirvi che si parte di nuovo da qui: come piace a me. Ragazzo conosce ragazza. Paolo, orfano pavido e bisognoso, si è perso
in mezzo alle luci stroboscopiche di un locale gay: cerca di
scongiurare il suo compagno affinché gli dia una seconda chance. Mia, volitiva sin dal nome, è
al sesto mese di gravidanza: ha bevuto troppo, si accascia tra le braccia di lui. Che è un
gigante buono dagli occhi tristissimi e, per carattere, non sa dire di no. Quella Madonnina con i tatuaggi e i capelli rosa lo
prende per mano e lo trascina a 1300 chilometri di distanza. Da
copione, ci si innamora o quasi nel mentre. Al centro: le chiacchiere
e le liti, le tappe che nessuno avrebbe immaginato. Alla
fine: una chiusa agrodolce, di quelle che se è la sera giusta sanno commuovere. Il
padre d'Italia è un dramma su ruote con un po' di Away We Go, un po'
di Una giornata particolare e tanta bellezza. Introspettivo, intimo, parlato a lungo, pone al
centro i suoi personaggi – caratterizzati con cura e pazienza,
vicini a me –, e la regia sincronizza di conseguenza il suo passo
al loro. L'irruenza della Ragonese e i silenzi carichi di Marinelli
(magnifico, e con un altro personaggio, dopo il memorabile Guido di Tutti
i santi i giorni, in cui ci sono i miei stessi punti di saturazione) chiamano a sé gli Smiths e la Bertè canticchiati piano, le lunghe carrellate e i personaggi di spalle, le ipnotiche luci al neon del cinema di Dolan. Mollo ha
lo sguardo indie che piace; l'alchimia di due che quei personaggi
intensissimi sanno portarli in vita con un gesto; lo sfondo in
movimento di un'Italia bigotta, con etichette che affibbiano sensi di colpa perfino all'amore. Paolo, troppo cerebrale di
suo, ne è pieno. E' contro natura che uno come lui diventi
genitore? E' contro natura, dopo la sofferta convivenza con un uomo, prendersi cura di una sciagurata che sfida il mare col petto in fuori e, a letto, gli ricorda quanto è caldo un altro corpo? Il liquido amniotico restituisce l'illusione di una
seconda infanzia; le donne insegnano a galleggiare. Il padre
d'Italia preferisce parlare d'appartenenza e istinto, senza sollevare polveroni. Di miracoli che, nella mano grinzosa
di una figlia, fanno riaffiorare il volto di una madre. Dell'emozione di sbagliare strada, scoprendosi lo stesso a casa. (7,5)
Sulle
montagne della Corea crescono una bambina ribelle e un maiale da
concorso, promesso ai banchetti di una spietata multinazionale.
Il consumismo rompe l'idillio. L'animale è caricato a forza in un furgone. La sua amica non si arrende: lo segue ovunque,
incrociando gli adepti della Mirando Corporation (Tilda Swinton,
novella Crudelia De Mon, e il cacciatore dell'esagerato Gyllenhaal) e un gruppo di animalisti reazionari (Dano e
la Collins, purtroppo poco utilizzati). Presentato a Cannes, l'ultimo Bong Joon-ho divideva perché non destinato alle
sale: Netflix rappresenta forse un danno? Il ginepraio ha
fatto sì che l'enorme animale domestico e il coraggio della sua
amica passassero quasi inosservati. Benché fosse lecito
aspettarsi qualcosa di più, soprattutto da una scrittura che accenna
ma non approfondisce, Okja è un film per famiglie che vorrebbe divertire e sensibilizzare: in parte, ci riesce. Con una delicata computer grafica che non fa rimpiangere la
rozzezza degli ultimi blockbuster e una regia al solito esemplare, la
fiaba del regista orientale – social ed eco-friendly – è
parzialmente irrisolta ma centrata. Ci si emoziona, ma senza
scontarsi con i picchi melodrammatici cari ai coreani (perfino
in Train to Busan, solido zombie-movie, toccava mettere
in conto fiumi di lacrime); si lotta affinché trionfino il lieto
fine e il candore dei bambini, ma tutto ha un prezzo. Un po' Babe in
chiave satirica, un po' E.T., Okja lascia
non abbastanza commossi da glissare sui punti oscuri della
sceneggiatura, ma ricorda il cinema di storie, sentimenti e illusioni
che mi ha reso un appassionato. Dove ci sono sia la forma che la
sostanza. Dove il vecchio (penso alle amicizie di Dahl, a Ende) incontra un nuovo modo di pensare
l'intrattenimento e, nel bene e nel male, ne ritocca i connotati.
(7)
Tutti
sono nell'occhio di The Circle, azienda futuribile che fa il verso al Grande Fratello di George Orwell. A
scoprirlo, una stagista che suo malgrado diventa un
esperimento che cammina. Fino a ritrovarsi, com'è
prevedibile, con le spalle al muro. Le tecnologie brevettate da un
aspirante Steve Jobs mostrano che un mondo senza segreti è un
mondo senza bugie. In nome del bene pubblico, però, si può mettere
in pericolo qualcun altro? Il best-seller di Dave Eggers sembrava
plausibile e inquietante. Al cinema, invece, il thriller su una
generazioni di esibizionisti e voyeur – pensate alle dirette su
Facebook, alle storie di Instagram, ai selfie in ogni dove:
all'esserci a tutti i costi – è inconcludente e confuso. Una delle
peggiori visioni dell'anno. Lungo spot di
Youtube da skippare, senza ritmo e senza tensione, The
Circle ha uno spunto tutt'altro che esecrabile ma di cui,
cosa che eppure accade perfino nelle peggiori trasposizioni, non ho
visto il potenziale tra le righe – di recuperare il romanzo perciò
no, non se ne parla. A remargli contro, due protagonisti che già ho poco
in simpatia: l'indigesto guru Tom Hanks, che ci grazia
con un ruolo marginale; una Emma Watson più rigida e fuori posto del solito, in vacanza o da Hogwarts o da una comune amish – fa
piacere intravedere però il bimbo cresciuto di Boyhood e
Bill Paxton, in una delle sue ultime apparizioni. Quanto sei social?
Quanto odieresti avere una telecamera addosso, se vivi comunque una vita online? Cos'hai da nascondere? A rischio, la privacy; il
futuro. Riflessioni brucianti ma scolastiche, troppe risposte eluse,
un'idea alle ortiche. Gli scarti di Black
Mirror non sfamano. (4)
 A
riprova di quanto sia stato un bambino strano, lo scarso interesse verso il ciclo arturiano. Non mi piaceva La spada nella
roccia e, più in là, ho
abbandonato per stanchezza la visione di Merlin e Camelot. Ci riprova Guy Ritchie – fratellastro ipodotato
di Rodriguez e Tarantino, con un paio di mancati cult nei primi anni
Duemila e una vita consacrata al gossip –, non pago di aver
profanato la tomba di Conan Doyle. Il giovane Artù, allontanato dal
palazzo reale, si muove tutt'altro che in sordina in una Londra
postmoderna. Lo zio usurpatore vuole eliminarlo; il nipote mira al colpo di stato. Che costi pure
qualche sacrificio, un tocco di magia, singolar tenzoni disputate al rallenty. Non mancano gli elefanti (in Inghilterra), il montaggio forsennato e una colonna sonora come un
martello pneumatico. I destrieri nerissimi, le torri in costruzione e
le immense adunate ricordano un Signore degli anelli in
cerca della compagnia del cattivo gusto. King
Arthur è confusionario e affollato. A
me, dopo il divertimento della prima parte, ha dato un mal di testa
che manco la prima e ultima volta in discoteca. Quello che appare
spassoso, dopo un po', viene infatti a noia. Quei salti qui e lì, più
lunghi della gamba, ispirano l'effetto collaterale di un conato. Law si tiene strette le smanie di potere del papa di Sorrentino e
qualche ghigno di troppo: la cosa più degna di meraviglia, nella sua
prova, è la la strenua lotta tra la stempiatura e la forza di
gravità. Un loquace e piacione Hunnam, riposto il chiodo,
ripiega sul fisico scolpito e un passato alla Oliver
Twist. Esagera con il gel effetto bagnato, obbligatoriamente
richiesto dal doppio taglio all'ultimo grido: l'unto della
brillantina potrebbe dargli più di qualche grana durante
l'incoronazione o, che Dio e il parrucchiere salvino le nostre anime, nell'eventualità di un sequel. (5)
A
riprova di quanto sia stato un bambino strano, lo scarso interesse verso il ciclo arturiano. Non mi piaceva La spada nella
roccia e, più in là, ho
abbandonato per stanchezza la visione di Merlin e Camelot. Ci riprova Guy Ritchie – fratellastro ipodotato
di Rodriguez e Tarantino, con un paio di mancati cult nei primi anni
Duemila e una vita consacrata al gossip –, non pago di aver
profanato la tomba di Conan Doyle. Il giovane Artù, allontanato dal
palazzo reale, si muove tutt'altro che in sordina in una Londra
postmoderna. Lo zio usurpatore vuole eliminarlo; il nipote mira al colpo di stato. Che costi pure
qualche sacrificio, un tocco di magia, singolar tenzoni disputate al rallenty. Non mancano gli elefanti (in Inghilterra), il montaggio forsennato e una colonna sonora come un
martello pneumatico. I destrieri nerissimi, le torri in costruzione e
le immense adunate ricordano un Signore degli anelli in
cerca della compagnia del cattivo gusto. King
Arthur è confusionario e affollato. A
me, dopo il divertimento della prima parte, ha dato un mal di testa
che manco la prima e ultima volta in discoteca. Quello che appare
spassoso, dopo un po', viene infatti a noia. Quei salti qui e lì, più
lunghi della gamba, ispirano l'effetto collaterale di un conato. Law si tiene strette le smanie di potere del papa di Sorrentino e
qualche ghigno di troppo: la cosa più degna di meraviglia, nella sua
prova, è la la strenua lotta tra la stempiatura e la forza di
gravità. Un loquace e piacione Hunnam, riposto il chiodo,
ripiega sul fisico scolpito e un passato alla Oliver
Twist. Esagera con il gel effetto bagnato, obbligatoriamente
richiesto dal doppio taglio all'ultimo grido: l'unto della
brillantina potrebbe dargli più di qualche grana durante
l'incoronazione o, che Dio e il parrucchiere salvino le nostre anime, nell'eventualità di un sequel. (5)
Un
tavolo per quattro, un rigido dress code. Da una parte siedono Coogan e la Linney, professore idealista con consorte. Dall'altra, invece, l'aspirante governatore Gere e Rebecca Hall, moglie trofeo. Il tema lo conoscete,
soprattutto se avete in libreria il romanzo di Koch o avete
intravisto la riuscita trasposizione italiana, I nostri ragazzi: figli colpevoli di un crimine orribile. Denunciarli o
proteggerli? Debitamente scandita dall'arrivo delle numerose portate,
la versione americana di Oren Moverman approfondisce
l'inconciliabilità dei fratelli Lohman, introducendo altre voci sul
menu. Digressioni ora azzeccate, ora
accessorie, che rimandano a data da destinarsi il momento di pagare
il conto e fan sì che, purtroppo, la riflessione centrale passi in
secondo piano – le nevrosi dell'uno e il politicamente corretto
dell'altro distolgono dalla ferocia delle mamme chiocce, dai moventi
un po' generalisti della nostra peggio gioventù. The Dinner,
scegliendo ristorante e cast stellati, fa i conti con la
retorica a stelle e strisce, un finale che non morde e la scelta
incomprensibile di rimandare il momento clou a
dopo il dessert. L'occhio, però, che ama il teatro e l'eleganza di certe messe in
scena (Moverman non è né Haneke né Polanski: ma scimmiotta quelli giusti, ha buon
gusto), è soddisfatto. La mise en place è da manuale, ma la
compagnia antipatica e i piatti pretenziosi. Quest'ultima cena si
dilunga, appesantisce, propone un conto salato. Squilibrata, acida,
nerissima. A ricordarci che la famiglia, talvolta, è il miglior
anticoncezionale. (6)