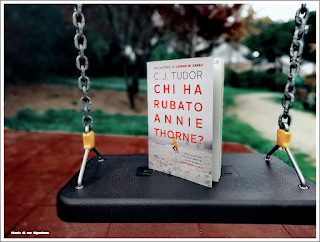L'inizio di questo romanzo dobbiamo sbircialo attraverso un finestrino ricoperto di brina. Dall'altra parte, a bordo di un treno di cui sono gli unici passeggeri, siedono compostamente un uomo e una donna senza nome. Il mezzo di trasporto scorre tra tunnel e foreste, muovendosi senza posa in coni d'ombra che resteranno impenetrabili fino all'ultima pagina. Le temperature sono prossime allo zero. Il paesaggio, fuori, è quello di un imprecisato paese nordico situato sopra il sessantesimo parallelo. Da qualche parte, non troppo distante, si agita un mare ghiacciato. La coppia newyorchese si è spinta fino alla fine del mondo per adottare un bambino, una creaturina paffuta che chiameranno Simon. L'umore, nonostante tutto, non è dei migliori. Sposati da una decina d'anni ma minacciati dalla sterilità, l'uomo e la donna fronteggiano in silenzio un ulteriore dramma: la malattia di lei, giunta al punto di non ritorno. Mentre lui resta lucido, realista ma sempre affettuoso, lei si trincera invece nella rabbia cieca: preferirà confidare nelle magie miracolose dei ciarlatani, anziché nelle inutili premure del compagno.
Ricorda, tutti ci sentiamo così. Viviamo in un'epoca buia, nessuno riesce a trovare la propria strada. Procediamo a tentoni, come i ciechi. Somigliamo a quegli animaletti sotterranei che scavano la terra fredda e umida nella speranza di trovare una radice commestibile. Noi non siamo migliori. […] Ma ci sono cose peggiori dell'essere ciechi e del procedere al buio, cose molto peggiori.
Amandosi tra alti e bassi, a dispetto dell'incomunicabilità crescente, l'uomo e la donna trascorrono la prima di una lunga serie di notti di neve in un hotel dal nome impronunciabile: una struttura kitsch, tutta moquette a pelo lungo e arabeschi fuori moda, che sembra un incrocio tra la quarta stagione di American Horror Story e una commedia pastello di Wes Anderson. Coloro che affollano il bar e la hall, però, sono proprio usciti da un film esistenzialista del miglior Paolo Sorrentino. Ciarlieri, malinconici e solitari, gli altri ospiti sembrano mossi da un'euforia ingiustificata. Sconvolgono le simmetrie dei dipinti di Hopper e, amichevoli, pronunciano soliloqui teatrali e raccolgono confessioni intime. Mentre l'acquavite scorre a fiumi e le sigarette bruciano fino al filtro, l'uomo e la donna faranno in particolare la conoscenza della deliziosa Livia Pinheiro-Rima – un'anziana artista in là con gli anni, con un passato rocambolesco e una vistosa pelliccia d'orso – e di Henk, un panciuto uomo d'affari pronto a importunare il protagonista con continue avance sessuali. Il pensiero dell'adozione passerà improvvisamente in secondo piano quando la coppia verrà a sapere dell'esistenza di un guaritore, fratello Emmanuel: se esistesse una cura, il protagonista – destinato a diventare vedovo – non avrebbe più bisogno della “toppa” di un neonato? Il mio primo Peter Cameron, iniziato a Halloween, parte da spunti fortemente sinistri.
Non ha niente a che fare con l'amore. La gentilezza – che parola orrenda – la riserviamo a chi non amiamo, a chi non possiamo amare. Siamo gentili con quelli che non amiamo proprio perché non li amiamo. È lì che entra in gioco la gentilezza: quando non c'è amore.
La coppia spogliata di un'identità, gli scenari innevati e le stranezze diffuse, accanto alle riflessioni sul disamore e sull'elaborazione dei traumi, mi hanno ricordato moltissimo i fasti di Sto pensandodi finirla qui: l'ultimo capolavoro di Charlie Kaufman dove ogni stranezza si abbinava a un simbolo preciso e il mistero angosciante, nella poesia dell'epilogo, si trasformava a sorpresa in un musical. Forse non il romanzo più adatto per una conoscenza preliminare, soprattutto perché i dubbi del lettore sul reale significato della storia non verranno mai fugati del tutto, Cose che succedono la notte è una lettura atipica e suadente, personale e onirica. Una terapia di coppia raccontata in un eterno dormiveglia, in cui lo stile di Peter Cameron – rassicurante e caldo, con i suoi dettagli vitali, con i suoi dialoghi veritieri – aiuta le pupille ad abituarsi all'assenza di luce. Non tutto torna al proprio posto, anzi: a ben vedere manca un senso manifesto, una morale scritta all'ultimo rigo, ma il viaggio è stranamente confortevole. Me ne sono accorto verso la conclusione, afflitto dalla malinconia che solitamente accompagna la fine delle vacanze: in questo limbo ci avrei messo le tende. Lì dove avrebbe potuto prevalere l'irritazione, infatti, trionfa una curiosità irresistibile nei confronti di una psichedelia alla Becket. Cose che succedono la notte è un'elaborazione dell'inconscio e del quotidiano: più che a un incubo, spesso e volentieri somiglia a un sogno. Di quelli di cui al risveglio - sensazione frustrante ma bella – vorresti correre ad appuntare i dettagli su un foglio volante. Sceso dal letto, purtroppo, non li ricordi più.
Il mio consiglio musicale: Patti Smith – Because the Night