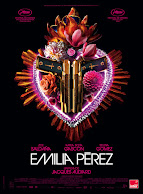giovedì 13 febbraio 2025
And the Oscar goes to: Emilia Pérez | Conclave | Maria | Nosferatu
sabato 15 gennaio 2022
Biografie da Oscar: Spencer | Belfast | King Richard | Being the Ricardos
A che serve l'ennesimo biopic, per di più con The Crown in corso d'opera, sull'icona più famosa al mondo? Ultimo ritratto di signora per Pablo Larraín, Spencer racconta i tre giorni di agonia di un matrimonio lungo dieci anni; la donna in pezzi prima del mito inscalfibile. Diana festeggia il Natale in un castello stregato in cui i riscaldamenti sono sempre spenti, le ceneri dei vecchi regnanti ricoprono ogni cosa e i servitori, invitati al silenzio, sono schierati come un esercito. Ma, aggrappata alla tazza in ghingheri come una sposa, Diana vomita, disobbedisce e semina dissensi: il suo tormento si manifesta con l'autolesionismo. In una scena già cult, si strappa la collana e ingoia le perle insieme a una zuppa immangiabile. Favola nera o forse horror dell'anima, il film è una psichedelia di danze, spettri e fagiani dove tutto, fatta eccezione per l'epilogo, è gelo. In questo inferno di ghiaccio, Kristen Stewart si rivela una scelta tanto azzardata quanto vincente: sorprendente con accento british, presta gli occhi malinconici e il temperamento nervoso a una figura in tensione perenne, in grado di sciogliersi soltanto al cospetto dei figli e di Sally Hawkins; i costumi da Oscar fanno il resto. Si può fuggire a un destino segnato? C'è spazio per i miracoli, in un mondo in cui perfino i bambini sono educati alla violenza della caccia? Per fortuna il buon cinema tutto può. Il qui e ora non esistono, sussurra Diana: passato, presente e futuro sono la stessa cosa. Il tempo si fonde come in Dalì, allora, e attraverso questo magma Diana Spencer può andare incontro alla vita (e alla morte) nei luoghi in cui è stata bambina spensierata. È possibile la stessa felicità? Basta lasciare in pegno il vestito buono agli spaventapasseri e, fanculo il mondo, inseguire «gli amori, lo shock e le risate». (8)
martedì 29 dicembre 2020
[2020] Top 10: Il mio cinema, nell'anno che il cinema ce l'ha tolto
10. His House: Presentato in anteprima al Sundance, un horror indipendente che racconta con i toni della ghost story la tragedia dell'immigrazione clandestina. Per riflettere, nello stile del cinema di Ken Loach, ma con qualche brivido in più.
9. Shirley: Un po' biopic, un po' thriller, purtroppo inedito in Italia, è un faro acceso sulla vita oscura di un'autrice famosissima – anzi famigerata – interpretata qui dalla camaleontica Elisabeth Moss. Per chi è affascinato dai meccanismi del parto creativo, soprattutto quando genera mostri.
8. Ema: L'ultima fatica del cileno Pablo Larraìn, all'indomani di innumerevoli film politici, si dedica anima e corpo a una storia controversa e passionale su una ballerina pansessuale e sul suo desiderio di maternità nonostante tutto. Contro natura, oltre natura.
7. Il buco: Poetico, politico, claustrofobico, è uscito nel clou del primo lockdown. Qualcuno lo ha amato, qualcuno lo ha odiato, qualcun altro ha amato odiarlo. Ma questa distopia spagnola a tinte forti – ambientata in un carcere verticale dove vige la legge del più forte – è forse il film più rappresentativo dell'anno.
6. Favolacce: Sono giovani, sono belli, sono volenterosi. Soprattutto, sono il futuro che il cinema italiano non sapeva di meritare. Fabio e Damiano D'Innocenzo, premiati in pompa magna per la miglior sceneggiatura allo scorso Festival di Berlino, sono infine giunti a seminare turbamento anche su Amazon Prime Video.
5. Swallow: Si chiama picacisco, ed è una compulsione che spinge a inghiottire oggetti di varia forma e natura per dar voce a un disagio interiore. È questo il tema di un esordio shock – un horror originale, elegante, femminista –, con una Bennett in fuga dalla sua gabbia dorata.
4. Soul: Lo abbiamo visto un po' tutti sotto Natale ed è stato il regalo più bello che il 2020 potesse farci. È l'ultimo capolavoro Disney-Pixar. Per me il film più maturo, adulto e profondo del filone.
3. Jojo Rabbit: Ai tempi non mi era piaciuto in realtà. Lo avevo definito innocuo, una favoletta più graziosa che bella. Però ci ripenso spesso e con emozione, e vorrei che il 2020 finisse proprio come finisce il film del premiato Waititi: ballando, con David Bowie in sottofondo.
2. Sto pensando di finirla qui: In pole position non poteva mancare lui, Charlie Kaufman, con un viaggio al termine della notte e della ragione folle, destabilizzante, logorante. Riempie prima di orrore, poi di nostalgia.
1. Sound of Metal: Negli anni Venti c'era il cinema muto. È possibile, oggi, un cinema sordo? Da quest'idea difficoltosa ma coraggiosissima parte un piccolo dramma disposto a farsi valere alla prossima stagione dei premi. Un'odissea lunga due ore interpretata da un incredibile Riz Ahmed, nel ruolo di un batterista che perde l'udito e sperimenta, così, un nuovo mondo. Quel mondo diventa anche il nostro. In un cinema che è esperienza umana, e condivisione.
mercoledì 23 dicembre 2020
Le visioni indie di dicembre: Sound of Metal | Ema | Matthias e Maxime | Waves | Under the Silver Lake
Lo cantavano Simon e Garfunkel: anche il silenzio ha un suono. Lo scopre d’un tratto Ruben, un batterista rock, all’improvviso costretto a rinunciare a un tour insieme alla compagna cantante. Perde l’udito. Ex tossicodipendente, fidanzato da quattro anni con la dolcissima Olivia Cooke e da quattro anni pulito, minaccia il suicidio; nega; si aggrava; nega ancora; distrugge. Al centro di un doloroso processo di accettazione, il protagonista si trasferisce in una comunità per non udenti dalle regole ferree. Quando gli ospiti – guidati da un Paul Raci in odore di nomination – comunicano fittamente fra loro nel linguaggio dei segni, sullo schermo non compaiono sottotitoli: lo smarrimento di Ruben, che non conosce la LIS, è pari al nostro. Questa è la grande sfida dell’esordio alla regia di Darius Marden: renderci vicinissimi all’esperienza del batterista. Complice un uso del sonoro mai sperimentato prima, Sound of Metal diventa allora una visione sperimentale, intima e immersiva: tagliati fuori, ma per questo perfettamente calati nel disagio di Ruben, ascoltiamo suoni ovattati, fischi, fruscii, tonfi, voci che sembrano rimbombare dalle profondità oceaniche. Gli anni Trenta erano il trionfo del cinema muto. Questo, invece, è un cinema sordo: capace di sfruttare le commoventi potenzialità della settimana arte per garantire totale empatia. Chiusi per due ore nella bolla della sordità, facciamo compagnia a un incredibile Riz Ahmed: l’attore di origini pachistane picchia i piatti della batteria con furia selvaggia e comunica resa a ogni sguardo. Artefice di una delle migliori performance su piazza, scrive pensieri farneticanti; impara pian piano a padroneggiare i movimenti delle mani, i vuoti, le parole non dette. Questo ex batterista fatica a riprendere il ritmo, ad abituarsi: insegue perciò l’utopia di un costosissimo impianto cocleare. Che rumore fa la disperazione? Cosa resta quando la musica finisce? A sorpresa, il silenzio – e l’oscurità, vecchia amica – garantiscono un’acustica perfetta. Marden li indaga sin nelle vibrazioni più infinitesimali. Il risultato, paradossalmente, è un’orchestra di emozioni. (8,5)
Dopo un viaggio in America che aveva dato vita al suo film più bistrattato – per me ingiustamente – Dolan torna alle origini per leccarsi le ferite. La provincia canadese è quella dei suoi primi successi, e sempre da lì vengono i miscugli particolarissimi tra inglese e francese, i rapporti di amore-odio con mamme troppo ingombranti, gli amori impossibili a tinte arcobaleno. Storia di un’amicizia messa all’improvviso in discussione, Matthias e Maxime parte con un bacio che i due protagonisti si scambiano per prendere parte a un corto cinematografico. Gli altri, intorno, non sembrano dar peso all’evento. Ma nei diretti interessati qualcosa cambia: contriti e confusi, prendono a evitarsi. Cosa nasconde il loro imbarazzo? Raccontati in presa diretta, sembrano muoversi senza seguire una sceneggiatura. Tra primissimi piani, dialoghi che si accavallano, brindisi e feste piene di armonia, permettono che l’incomunicabilità generi momenti di tensione. Riusciranno a confessarsi l’inconfessabile? Concitato, caotico e festoso, l’ultimo film dell’ex ragazzo prodigio mantiene un basso profilo. Tende a non strafare. Intimo, è al servizio di una storia semplice e priva di manierismi, che ovviamente non rinuncia ai classici riferimenti pop: la scena del bacio, la più memorabile, omaggia Titanic. Più sentito che riuscito, il film – fatto di esterni gelidi e d’interni calorosi, di un’allegria sguaiata intrisa di disperazione – è una festa di addio per salutare per sempre l’ultimo scampolo della giovinezza di Xavier. Ma è comunque una festa. (6,5)
Lo hanno abituato a eccellere. Afroamericano in un Paese intollerante, checché se ne dica, deve fare sforzi sovraumani per essere all’altezza delle aspettative altrui. Studente brillante e stella del wrestling, è spinto oltre i suoi limiti – o fino ai suoi limiti? – dalle pressioni di un padre troppo normativo. Come venire a patti prima con un infortunio, poi con l’arrivo di un bambino indesiderato, se nel suo futuro non sembravano esserci spazio per gli errori? Chi ha tutto, purtroppo, a tutto da perdere. E durante un ballo scolastico sotto antidolorici, la tensione crescerà fino a sfociare nella tragedia immancabile. Allora il film cambia aspect ratio e volto, cambia protagonista. Si lascia spazio al punto di vista della sorella minore, aspirante veterinaria alle prese con il primo amore per un tenerissimo Lucas Hedges. Waves – arrivato in homevideo con il sottotitolo Le onde della vita – è un dramma familiare con un bagaglio emotivo pesantissimo e una generosità fuori dall’ordinario. Potente, emozionante, vero, segue un andamento imprevedibile e tumultuoso. Sembra scosso dalle forze crudeli di una moderna tragedia. Parabola sull’ira e sul perdono, sulla disperazione e sulla libertà, scioglie i nodi intricati della prima parte con l’espiazione della seconda. Tra danze liberatorie sotto la luna, sbronze e faccia a faccia urlatissimi, riflette sulla mutevolezza delle sorti e dei sentimenti. Diretto da Trey Edward Shults – già notato con un interessante horror indipendente –, qui e lì è stato accusato di essere troppo pretenzioso. Con i suoi folgoranti primi piani, con le luci al neon e i colori fluo, con scene madri su scene madri, probabilmente lo è. Il montaggio da videoclip, inoltre, è una montagna russa. Ma il regista trentaduenne si è fatto le ossa come assistente di Terrence Malick, e si nota nella perfezione della messa in scena che ricorda anche le sperimentazioni visive di Dolan, le giovinezze allo stato brado di Guadagnino, i drammi all black di Jenkins. Strizzando l’occhio ai migliori, Shults cura maniacalmente la forma, però non scorda il cuore. Rinfrancato nello sguardo e nell’anima, mi sono goduto moltissimo questo doppio romanzo di formazione dove l’incomunicabilità prolifera per lasciare spazio al senso di colpa. Sui cocci della perfezione infranta, Waves regala picchi e creste. Travolge. Nelle sue onde, che ti circondano come un bozzolo, puoi o annegare o salvarti. (7,5)
mercoledì 22 febbraio 2017
Mr. Ciak - And the Oscar goes to: Moonlight, Fences, Jackie
 3 Nominations. Ho
visto il video dell'omicidio Kennedy all'ora di
inglese. Un colpo di fucile contro il presidente. Sua
moglie, di rosa vestita, cerca di fermare il sangue. Di recuperare, in
un gesto insensato, i pezzi di cervello dalla carrozzeria. Jackie,
atipico biopic del cileno Larraìn, racconta le ore successive
all'attentato. Ritratto psicologico originale, non lineare nella sua scrittura.
Emozionale, non emotivo. A mio dire, non emozionante. Si sofferma su un lutto intriso di rigore.
Su spazi vitali stipati di persone. La protagonista appare di rado sola. Si
tiene addosso quel tailleur chiazzato di sangue più del dovuto. Deve predisporre una
solenne parata, così come tempo prima aveva badato ai tappeti della
Sala Ovale. Fuma, ma vieta che il dettaglio trapeli. Si mostra
capricciosa, frivola e antipatica, risoluta. Natalie
Portman, assente dalle scene dopo i fasti del Cigno
Nero, è somigliante in maniera
maniacale. Fin troppo? Ti fa pesare, infatti, la sua splendida prova. Ostenta
la perfezione raggiunta, una fatica che c'è ma che non vuole si
veda. Così tanto brava – dall'accento sospiroso al portamento
impeccabile – da risultare petulante. Jackie,
d'altronde, non doveva brillare per simpatia. Così presa dal suo
ruolo, tanto calata nella parte di first lady,
da confondere lato pubblico e lato privato. Razionalmente ho capito
le ragioni dei bronci e la grande rabbia per l'idillio che si
incrina. Dal punto di vista stilistico, poi, mi allineo a chi l'ha
trovato impeccabile. Emotivamente, però, mi ha lasciato infastidito. E puoi essere il più curato dei film, ma se
mi parli di una donna addolorata nel profondo e quel dolore io non lo
vivo, non lo percepisco, allora puoi dirti riuscito solo a metà. Sono tutti bravissimi, tutto è bellissimo. Ma l'ho ammirato con
freddezza, stando al di qua dell'uscio. La futura signora Onassis non
si svela. L'icona è diventata inscindibile dalla donna. Doveva credere
talmente tanto in Camelot – un sogno impossibile, condiviso insieme
all'America – da diventare un personaggio fittizio. Incapace di abbandonare quella parte. Quelle
stanze in cui beve vino costoso e sfila, anche quando nessuno la
guarda più. (6,5)
3 Nominations. Ho
visto il video dell'omicidio Kennedy all'ora di
inglese. Un colpo di fucile contro il presidente. Sua
moglie, di rosa vestita, cerca di fermare il sangue. Di recuperare, in
un gesto insensato, i pezzi di cervello dalla carrozzeria. Jackie,
atipico biopic del cileno Larraìn, racconta le ore successive
all'attentato. Ritratto psicologico originale, non lineare nella sua scrittura.
Emozionale, non emotivo. A mio dire, non emozionante. Si sofferma su un lutto intriso di rigore.
Su spazi vitali stipati di persone. La protagonista appare di rado sola. Si
tiene addosso quel tailleur chiazzato di sangue più del dovuto. Deve predisporre una
solenne parata, così come tempo prima aveva badato ai tappeti della
Sala Ovale. Fuma, ma vieta che il dettaglio trapeli. Si mostra
capricciosa, frivola e antipatica, risoluta. Natalie
Portman, assente dalle scene dopo i fasti del Cigno
Nero, è somigliante in maniera
maniacale. Fin troppo? Ti fa pesare, infatti, la sua splendida prova. Ostenta
la perfezione raggiunta, una fatica che c'è ma che non vuole si
veda. Così tanto brava – dall'accento sospiroso al portamento
impeccabile – da risultare petulante. Jackie,
d'altronde, non doveva brillare per simpatia. Così presa dal suo
ruolo, tanto calata nella parte di first lady,
da confondere lato pubblico e lato privato. Razionalmente ho capito
le ragioni dei bronci e la grande rabbia per l'idillio che si
incrina. Dal punto di vista stilistico, poi, mi allineo a chi l'ha
trovato impeccabile. Emotivamente, però, mi ha lasciato infastidito. E puoi essere il più curato dei film, ma se
mi parli di una donna addolorata nel profondo e quel dolore io non lo
vivo, non lo percepisco, allora puoi dirti riuscito solo a metà. Sono tutti bravissimi, tutto è bellissimo. Ma l'ho ammirato con
freddezza, stando al di qua dell'uscio. La futura signora Onassis non
si svela. L'icona è diventata inscindibile dalla donna. Doveva credere
talmente tanto in Camelot – un sogno impossibile, condiviso insieme
all'America – da diventare un personaggio fittizio. Incapace di abbandonare quella parte. Quelle
stanze in cui beve vino costoso e sfila, anche quando nessuno la
guarda più. (6,5)