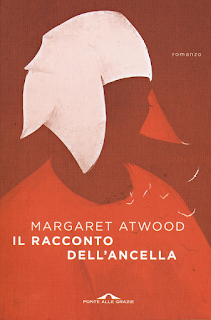| Pancia
d'asino,
di Andrea Abreu. € 15, pp. 150 |
Qualcuno, non troppo a torto, le ha definite le Lila e Lenù dell'isola di Tenerife. Amiche per la pelle, ma all'occorrenza anche rivali spietatissime, condividono le barbie e le estati. Hanno caratteri spigolosi e, nonostante i loro dieci anni, guardano tutti dall'alto in basso. Ogni giornata è una sfida per primeggiare. Ogni arrivederci è struggente. Appaiate come certi yogurt, forse predestinate, si presentano a noi lettori al termine della scuola per poi salutarci con il sopraggiungere di settembre. Prevedibilmente lasceranno intonso il libro delle vacanze. Hanno troppo da sperimentare, troppo da vivere. Quale sapore hanno l'anice, il caffè o il piccante? È vero che nel bosco vivono streghe che imbrattano di escrementi gli usci delle case? Quanto è spaventoso il sesso, quanto è lontano il mare? Lontane dai residence dei turisti, separati dagli abitanti locali da una specie di strato di pellicola, le piccole protagoniste giocano a fare cose da grandi e puoi immaginarle incedere da lontano tra il gracidare delle rane e il rombare delle betoniere: camminano scortate da uno stuolo di cani randagi e, a ogni passo, si pizzicano le mutande finite nel sedere.
In quel momento, quando il manto di nuvole si apriva in crepe sottili sottili, l'ultima luce del giorno cominciava a trapassare il cielo e tutto diventava d'oro brillante. Mi veniva un'angoscia fortissima al petto, come se mi mancasse il respiro. Io non sapevo mai salutare Isadora. La guardavo come una che dovevo salutarla per molti anni. Ma Isadora mi accompagnava a casa. Mi accompagnava sempre. E poi io accompagnavo lei. E lei accompagnava me. Propio come le confezioni di iogur del negozio, aveva detto lei una volta. Lo aveva detto parlando di noi pensando che non la sentissi, e invece sì. Come le confezioni di iogur che sono sempre a due a due.
La narratrice, soprannominata Shit, vive all'ombra Isora: preda di un'adorazione ossessiva, fagocitante, che un po' somiglia all'amore e un po' a nient'altro. Mentre la prima è duttile e poco intraprendente, l'altra è la reginetta del barrio: nipote della proprietaria dell'unico alimentari in zona, parla senza vergogna ai ragazzi e agli adulti e con il suo sguardo impenetrabile, con i suoi denti infallibili, divora il mondo in maniera bulimica. Shit, però, vorrebbe conoscere anche gli abissi in cui talora sprofonda: dove finisce Isora quando la tristezza è così forte che pensa di farla finita? Immerse in un sudicio canale, qualche volta chiudono gli occhi e pensano al mare: vicino eppure irraggiungibile. Spregiudicato, selvaggio e bellissimo, l'esordio di Andrea Abreu – classe 1995 – somiglia alla lava incandescente che un giorno potrebbe far sprofondare all'inferno l'isola e i suoi abitanti. Sorto all'ombra di un vulcano, il quartiere descritto dall'autrice ha gli odori forti, le feste patronali e i palazzoni abusivi del nostro Sud Italia. Perennemente sormontato da una cappa di basse nuvole grige – il titolo del romanzo si riferisce a questo preciso fenomeno meteorologico –, vive in uno stato di pigra sospensione. Cosa avrà in serbo il cielo: pioggia scrosciante o sole?
Nei giorni che Isora voleva morire sentivo anch'io che volevo morire e lei mi diceva che il modo migliore di morire era riempire d'acqua calda la vasca da bagno fino all'orlo e tagliarsi le vene. Io mi domandavo come faceva a sapere tante cose che io non sapevo e allora diventavo triste perché pensavo che io non avevo una tristezza mia, che la mia tristezza era la sua ma dentro di me, una tristezza come d'imitazione, una tristezza copiata, una tristezza tarocca, quello ero io, perché io non avevo motivi per essere triste ma me li inventavo.
Corrono i primi anni Duemila, gli stessi della mia infanzia. Shit e Isora ascoltano le canzoni degli Aventura con l'mp3, scrivono su Messenger, guardano i Simpson e Walker Texas Ranger, sbraitano contro contro il telegiornale quando la notizia della caduta delle Torri gemelle interrompe i loro intrattenimenti preferiti. Ma si sbucciano anche le ginocchia a sangue, simulano atti sessuali con le bambole, si masturbano con i pennarelli colorati, si inducono il vomito o la dissenteria. Ricordate com'era avere dieci anni, tabù compresi? A differenza di Elena Ferrante, sempre impeccabile, Abreu è incuriosita dalle pelurie, dai fluidi corporei, dal contatto fisico, dalle storture. La scrittura, innovativa, si adegua alla sua voce: la lingua di Pancia d'asino è un esperanto euforico, sgrammaticato, volgare, fatto di uno slang americano scimmiottato alla bell'e meglio e di una punteggiatura spesso assente (bravissima la nostra Ilide Carmignani, chiamata questa volta non a tradurre alla lettera, bensì a inventare). A volte credo di vederla con la coda dell'occhio, Shit. Eccola, mossa da sentimenti spaventosamente adulti, che supera i confini tracciati e insegue il sole. Magari si spingerà oltre il barrio, oltre l'amicizia con Isora, fino alla fine del mondo.
Il mio consiglio musicale: Gaia – Nuvole di zanzare