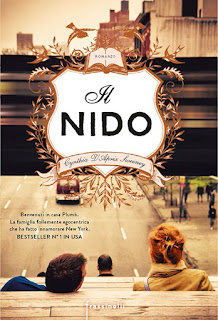Tu sei quello che va e viene, io sono quello che resta. Come sempre, no?
Titolo:
Le otto montagne
Autore:
Paolo Cognetti
Editore:
Einaudi
Numero
di pagine: 199 pagine
Prezzo:
€ 18,50
Sinossi:
Pietro
è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La madre
lavora in un consultorio di periferia, e farsi carico degli altri è
il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e
affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia.
I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune, fondativa: in
montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati
ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da
sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li
riempie ora di rimpianto e nostalgia. Quando scoprono il paesino di
Grana, ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto
giusto: Pietro trascorrerà tutte le estati in quel luogo "chiuso
a monte da creste grigio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola
l'accesso" ma attraversato da un torrente che lo incanta dal
primo momento. E li, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa
e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma invece di essere
in vacanza si occupa del pascolo delle vacche. Iniziano così estati
di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i
sentieri più aspri. Sono anche gli anni in cui Pietro inizia a
camminare con suo padre, "la cosa più simile a un'educazione
che abbia ricevuto da lui". Perché la montagna è un sapere, un
vero e proprio modo di respirare, e sarà il suo lascito più vero:
"Eccola li, la mia eredità: una parete di roccia, neve, un
mucchio di sassi squadrati, un pino". Un'eredità che dopo tanti
anni lo riavvicinerà a Bruno.
La recensione
“Ci
guardavamo per un secondo. Tutto qui. Non se ne accorgeva nessuno, né
succedeva di nuovo nel corso della serata, e io non ero sicuro di
interpretare bene il significato di quel saluto. Poteva voler dire:
mi ricordo di te, mi manchi. Oppure: sono passati due anni ma sembra
una vita, non ti pare?”
Sono
nato su un'isola. Ho avuto la fortuna di viaggiare un po', con la
scuola, e ho visto in minima parte quello che c'è fuori – Londra,
Barcellona e la Grecia, a bordo di un autobus che s'inclinava
pericolosamente nelle curve a gomito –, pur conoscendo poco
dell'Italia. Non mi sono mai spinto più a nord di Ravenna. Sono del
sud. Un topo di città. Un tipo da mare che però odia la spiaggia.
La natura non si fida di me, io non mi fido della natura. Mi
spaventa, quasi. Perché sono stato un ragazzino grasso e impacciato,
che cascava anche da seduto. Perché studio in Abruzzo, vedo il Gran
Sasso imbiancato arrivando in treno e so che, per DNA, siamo piccoli
e frangibili. Non sono mai stato in montagna, e delle montagne so
soltanto che sono quelle rocce alte e appuntite, con le cime
innevate, che mi si parano all'orizzonte mentre viaggio per le strade
di certe città. Quando ero più piccolo, ha provato a farmi cambiare
idea Mauro Corona: uno scrittore avventuroso, che la natura la ama e
la racconta da sempre, ma che con me, purtroppo, aveva fatto
fatica.
Una sera di gennaio, però, mi sono ritrovato a leggere
un romanzo che la natura ce l'ha perfino nel titolo. A detta
dell'autore, una storia di due amici e una montagna. Così tanta la
voglia di scoprire il fortunato Paolo Cognetti, però, da vincere
perfino le vertigini e l'insofferenza verso la vita all'aria aperta.
L'autore – uno di quelli che piacciono a me, che scrive come parla
e parla come mangia – presta la sua voce a Pietro: un bambino con
due genitori che si sono conosciuti sulle Dolomiti, un appartamento
al centro dell'irrespirabile Milano, una serie di estati tutte
uguali. Quando le scuole chiudono, mamma (assistente sociale) e papà
(operaio) vanno in ferie e alloggiano a Grana, tra le loro amate
montagne. Non si somigliano, Pietro e suo padre: così chiusi da non
riuscire a trovare punti in comune, se non le esplorazioni e
l'arrampicata. Assicurati dalla stessa imbracatura, legati stretti,
possono provare finalmente un illusorio senso di familiarità. La
montagna regala a Pietro qualche attimo felice con il genitore,
malinconico cronico con la testa altrove, e un migliore amico di nome
Bruno. Un coetaneo che se ne sta sempre lì, con le mucche e il
gregge, cresciuto a pane e romanzi d'avventura, come se a separarlo
dalla valle ci fosse una barriera. Si vedranno ogni estate per
trent'anni. Non si daranno mai appuntamento e di rado si parleranno
da un telefono a gettoni.
Ogni volta, si incontreranno quasi per
caso: come se, lassù, ci si potesse incrociare come tra
dirimpettai. Le otto montagne racconta la
spensieratezza dell'infanzia, le frenesie dell'adolescenza e, infine,
le eredità che ci riportano a casa. Il rivedersi tanti, troppi, anni
dopo e il contarsi i capelli grigi in testa, parlando di seppellire
padri, costruire casupole, perdere un amore. Prende spunto, nelle sue
riflessioni esistenziali, da una leggenda nepaliana. Soprattutto, si
intuisce nei ringraziamenti, dalla gioventù dello stesso Cognetti:
figlio degli anni Ottanta, uomo concreto e dall'indole nomade, che
viene dalla Lombardia e dal racconto breve. Nel suo ultimo lavoro, il
primo firmato con Einaudi, ho trovato i ragazzi e le ragazze di
quella generazione; il fare pragmatico e i viaggi per trovare sé
stessi; il settentrione e quelle parole setacciate, centellinate,
coltivate con parsimonia. A me, in teoria, Paolo Cognetti non
dovrebbe piacere: non qui, almeno. Non vi nascondo che, a tratti, con
la guida di un protagonista errabondo e introverso, rischiavo di
restare indietro di qualche passo. Però c'è che Bruno, un
personaggio indimenticabile come pochi, compare in scena e ti
emoziona. Perché lui, che eppure scuoia gli animali a mani nude,
spala letame da mattina a sera, ha dita nodose e comportamenti da
misantropo, è artefice di una poesia tutta sua. E c'è che Le
otto montagne è un romanzo intensissimo, commovente, dove
gli stati d'animo seguono i bollettini metereologici e i bambini
vengono al mondo in ottobre, ché l'amore si fa quando i campi
riposano. Ti scalda in questo inverno che non ha pietà. E lo sa la
testa, e lo sa la pancia.
Il
mio voto: ★★★★½
Il mio consiglio musicale: Ed Sheeran - Castle On The Hill
Il mio consiglio musicale: Ed Sheeran - Castle On The Hill